ufficio stampa e redazione web: rassegna quotidiani locali
15 dicembre 2006
R A S S EG N A W E B
Qui si seguito 9 articoli pubblicati tra il 5 e il 15 dicembre 2006 dalle testate: Il Riformista, Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, L’Altra Voce, L’espresso
1 - Il Riformista del 5 dicembre 2006
Università: quei paragoni con l’estero fatti a uso degli amici
Nella comparazione tra il sistema italiano e quello britannico i dati sono strumentalizzati per dimostrare una propria tesi preconfezionata Finalmente, le «sacre scritture» più volte citate negli articoli di Giavazzi, Alesina e altri economisti, che dichiarano irrimediabile la condizione dell’università italiana, e suggeriscono al governo di tagliarne i finanziamenti, sono disponibili a tutti. Lo stesso "Profeta", autore delle «sacre scritture», il citatissimo professor Roberto Perotti, ne ha pubblicato una versione aggiornata, avendo a disposizione un’intera pagina del Sole 24 0re del 30 novembre. Si può ora discutere, in qualche dettaglio, una fonte acriticamente invocata come certa e inoppugnabile, dai teologi del Dio Mercato che continuano a dominare le pagine dei grandi quotidiani sui problemi dell’università. Si può finalmente osservare che l’articolo di Perotti è un esempio da manuale di come dati statistici apparentemente obiettivi possano essere messi al servizio di una tesi preconcetta.
La tesi di Perotti è che il sistema universitario britannico è molto più efficiente e produttivo di quello italiano, come testimoniato dalla spesa media per studente e dal rapporto studenti/docenti nei due paesi. Che dire innanzitutto di questa tesi? Io penso che ci sia moltissimo da imparare dall’esperienza inglese nelle politiche dell’istruzione superiore, e in particolare dalla loro capacità di adottare politiche coraggiose e di analizzarne gli effetti per correggerne il tiro, anche radicalmente. Tuttavia un confronto diretto tra i sistemi universitari dei due paesi sulla base di dati grossolani non ha proprio senso. In Gran Bretagna il sistema universitario è, per la metà circa, costituito da università, che sono nate come istituzioni parauniversitarie, dove ai docenti non veniva nemmeno chiesto di impegnarsi nella ricerca. In molti casi l’istruzione fornita da queste istituzioni non era di livello molto diverso da quello che era offerto dai nostri migliori istituti tecnici. II grande e interessantissimo esperimento inglese di valutazione della ricerca scientifica che va sotto il nome di RAE (Research Assessment Exercises) ha avuto principalmente l’effetto di ribadire la distinzione tra università di serie A e università di serie B, dopo che, nel 1992, tutte le istituzioni parauniversitarie erano state formalmente promosse al rango di università. In Italia, questa distinzione è impossibile, come ha testimoniato il nostro esperimento di valutazione della ricerca, che imita quello inglese, e che si è concluso quasi un anno fa. Le nostre valutazioni hanno confermato che ricerca ritenuta «eccellente» si svolge, in ogni arca, in tutte le grandi e medie sedi universitarie.
La tesi di Perotti è che il sistema universitario britannico è molto più efficiente e produttivo di quello italiano, come testimoniato dalla spesa media per studente e dal rapporto studenti/docenti nei due paesi. Che dire innanzitutto di questa tesi? Io penso che ci sia moltissimo da imparare dall’esperienza inglese nelle politiche dell’istruzione superiore, e in particolare dalla loro capacità di adottare politiche coraggiose e di analizzarne gli effetti per correggerne il tiro, anche radicalmente. Tuttavia un confronto diretto tra i sistemi universitari dei due paesi sulla base di dati grossolani non ha proprio senso. In Gran Bretagna il sistema universitario è, per la metà circa, costituito da università, che sono nate come istituzioni parauniversitarie, dove ai docenti non veniva nemmeno chiesto di impegnarsi nella ricerca. In molti casi l’istruzione fornita da queste istituzioni non era di livello molto diverso da quello che era offerto dai nostri migliori istituti tecnici. II grande e interessantissimo esperimento inglese di valutazione della ricerca scientifica che va sotto il nome di RAE (Research Assessment Exercises) ha avuto principalmente l’effetto di ribadire la distinzione tra università di serie A e università di serie B, dopo che, nel 1992, tutte le istituzioni parauniversitarie erano state formalmente promosse al rango di università. In Italia, questa distinzione è impossibile, come ha testimoniato il nostro esperimento di valutazione della ricerca, che imita quello inglese, e che si è concluso quasi un anno fa. Le nostre valutazioni hanno confermato che ricerca ritenuta «eccellente» si svolge, in ogni arca, in tutte le grandi e medie sedi universitarie.
Vediamo invece come il professor Perotti riesce a utilizzare dati molto grossolani per sostenere la sua tesi. Il primo dato è il rapporto tra studenti dei corsi di laurea (esclusi gli studenti laureati) e i docenti di ruolo. I numeri così ottenuti, però, non gli danno ragione. Ci sarebbero 20 studenti per docente in gran Bretagna e 30 in Italia. Giustamente, Perotti osserva che in Italia tra gli studenti vengono contati i fuori corso, che dovrebbero pesare meno in termini di impegno didattico. Introduce quindi il parametro di studente «equivalente a tempo pieno» (ETP). Per la Gran Bretagna questo significa contare gli studenti dichiaratamente a tempo parziale in proporzione al loro impegno. In Italia, invece, sono considerati a tempo parziale tutti gli studenti in ritardo con gli studi, in proporzione al ritardo. In pratica, tutti gli studenti italiani sono considerati in diversa misura come studenti a tempo parziale.
Il divario tra lunghezza legale e lunghezza effettiva degli studi universitari è uno dei difetti gravi del nostro sistema, che la riforma universitaria si proponeva di correggere, e in parte ha corretto. L’assurdo era, ed è, che proprio per uno studente a tempo pieno risultava impossibile completare il corso di laurea nei tempi ufficialmente previsti. Giustamente il ministero ha introdotto, attraverso il parametro utilizzato da Perotti, una misura di questa stortura, per aiutarne la correzione, ma è una vera forzatura utilizzare questa misura per un confronto internazionale, perché molti degli studenti ritardatari sono invece effettivi studenti a tempo pieno secondo gli standard internazionali. Tuttavia nemmeno questa forzatura dei dati è sufficiente al professor Perotti per raggiungere il suo obiettivo. Anche in termini di studenti etp il rapporto studenti/docenti di ruolo risulta lo stesso nei due paesi: 15 per la Gran Bretagna, 14,9 per l’Italia. È a questo punto che Perotti è costretto, per sostenere la sua tesi, a cambiare i denominatori dei rapporti. Si aggiungono ai docenti permanenti delle università inglesi i docenti che non hanno un contratto a tempo indeterminato, e ai docenti delle università italiane i «docenti a contratto» e altre figure minori, infine ai dati sui docenti inglesi si sottraggono i non meglio determinati «docenti impegnati solo nella ricerca».
A questo punto, finalmente, i dati rispondono alle aspettative del professor Perotti, il rapporto studenti/docenti scende a 9,7 per la Gran Bretagna e a 7,5 per l’Italia.
Ma chi sono i «docenti a contratto» italiani che Perotti ha introdotto nel denominatore? Nelle università statali (a quelle non statali si applica invece uno speciale codicillo) sono esperti, rigorosamente esterni ai ruoli universitari, che, di regola, non sono titolari di un insegnamento ufficiale, ma sono invitati a presentare aspetti particolari, spesso applicativi, della materia insegnata. Alle loro lezioni, che si riducono a poche ore, assiste, normalmente, anche il titolare dell’insegnamento. Aggiungere queste figure al totale dei docenti universitari italiani non ha senso ai fini comparativi, ma era assolutamente necessario per dimostrare la tesi di Perotti, e cioè che i docenti universitari italiani sono troppi. In realtà il professor Perotti non manca di rilevare (con argomenti sbagliati) che l’inclusione dei docenti a contratto nel totale dei docenti italiani dà luogo a una sovrastima del numero dei docenti, ma si guarda bene dal parlarne quando tratta del rapporto studenti/docenti. Lo nota invece, confidando nella disattenzione del lettore, quando scopre che nonostante l’uso improprio, come vedremo, di un tasso di cambio artificioso, il costo medio di un docente italiano risulterebbe inferiore a quello di un docente inglese.
La seconda tesi di Perotti è che in Italia la spesa per studente universitario è superiore (o almeno non troppo diversa) dalla spesa nel Regno Unito. Sembrerebbe naturale a un ignaro lettore di giornali, paragonare le due spese, in euro e in sterline, utilizzando il cambio ufficiale. Perotti, invece, astutamente introduce un’altra unità di misura il cosiddetto «Ppp (Purchasing power parities) dollar» che tiene conto del diverso costo della vita nei due paesi. Paragoni internazionali che utilizzano questa variabile hanno certamente senso se sa vogliono confrontare i livelli di consumo delle famiglie, la distribuzione del reddito disponibile, i livelli di povertà, o i salari netti. Non ha senso invece utilizzare questa variabile per paragonare la spesa sostenuta dalle università per sostenere il servizio didattico. Cosa c’entra il prezzo del pane o del latte, o comunque il "paniere" delle spese prevalenti nelle famiglie, con le spese che deve affrontare una sede universitaria?
Per fare un esempio, nel determinare il Ppp dollar non si tiene certamente conto del costo del lavoro a parità di salario netto, che in Italia, in virtù di un maggiore cuneo fiscale è superiore a quello di altri paesi.
Eppure il costo del lavoro al lordo delle tasse e contributi è un elemento determinante nelle spese per una attività dabour intensive come è quella didattica. II buffo è che nonostante la forzatura di scegliere le due
variabili addomesticate del "Ppp dollar" e dello studente Etp, la spesa media per studente (non laureato) in Gran Bretagna, risulta del 27% superiore a quella italiana. Nel Regno Unito si spendono 4.200 "Ppp dollar" in più per ogni studente Etp. Calcolando le percentuali a scalare, come astutamente fa il professor Perotti, il divario scende al20%. Tanto basta per far proclamare a Perotti che si tratta di un «divario non drammatico».
V’è un’altra interessante omissione che deve esse rilevata. Il professor Perotti non può` non ricordare che nel suo scritto originario, che utilizza i dati del 1999 2000, la spesa media per studente italiano, calcolata sempre in termini di studenti Etp e di "Ppp dollari" era molto superiore alla spesa per studente inglese. Dal 2000 al2004 la spesa media per studente Etp (non laureato) in Italia è scesa da 16.854 a 15.400 "Ppp dollar", mentre, calcolata allo stesso modo, in Gran Bretagna è cresciuta da 12.435 a 19.600 "Ppp dollar". Si sono invertite in termini di percentuali le posizioni dell’Italia e della Gran Bretagna. Per chi, come me, non crede a queste stime grossolane, queste variazioni non hanno molto significato. Come è possibile tuttavia che il professor Perotti, che sembra credere a queste stime, non abbia concluso dai suoi stessi dati che l’università italiana è avviata a un luminoso futuro avendo superato il sistema inglese in termini di efficienza? Dobbiamo alla fine chiederci come sia possibile che uno stimato economista si dedichi a simili equilibrismi con dati statistici non sufficientemente disaggregati. Come è possibile che altri stimati studiosi lo citino acriticamente? La risposta, io credo, è nelle passioni suscitate nel professor Perotti e negli altri professori che scrivono sull’università, dal vero problema che sta loro a cuore, che non sono le sorti degli studenti o del Paese, ma piuttosto l’esito dei concorsi a cattedra nelle loro discipline. Per questo dobbiamo esser grati al professor Perotti, che non si è limitato, come molti suoi colleghi, a pochi accenni al problema che gli sta veramente a cuore, ma ha pubblicato nella pagina messagli a disposizione dal Sole 24 Ore un piccolo saggio sulle beghe concorsuali del suo settore disciplinare. Uno scritto incomprensibile, credo, alla maggioranza dei lettori, me compreso, che testimonia però dove batte il cuore dell’autore. Se il cuore batte sulle beghe concorsuali, sui contrasti tra scuole diverse, sulle «capre» o gli «asini» che vengono promossi, scavalcando i nostri allievi, i nostri amici o noi stessi, non si può guardare con occhio equanime il sistema universitario. Il problema delle promozioni di quarantenni o cinquantenni che già insegnano nelle università è importantissimo per i diretti interessati, le loro famiglie, i loro amici e i loro sostenitori, ma è di scarso rilievo per l’università, la ricerca e gli studenti.
2 - Il Riformista del 5 dicembre 2006
La ricerca non si valuta solo con la conta delle pubblicazioni
Quale standard adottare per misurare la qualità e Maria Cristina Marcuzzo
Quale standard adottare per misurare la qualità e Maria Cristina Marcuzzo
Si fa presto - anche se si fa sempre bene - a invocare la valutazione della ricerca come criterio per la distribuzione dei fondi pubblici o in generale per l’upgrade del sistema universitario italiano. Ma se la parola «valutazione» viene issata solo come una bandiera, si rischia di trovarsi senza compagnia. L’esperienza del Civr (Comitato interministeriale per la valutazione della ricerca) o il progetto governativo di un’Agenzia per la valutazione mostrano che esistono diversità di vedute che non possono essere semplicemente liquidate come zizzania da estirpare per far crescere l’erba buona. Lo dimostrano la presentazione di una relazione di minoranza di un autorevole componente del panel 13 (Economia e statistica) del Civr, Luigi Pasinetti, e le recenti dimissioni di Walter Tocci (responsabile Ds dell’area università e ricerca) sull’articolo della finanziaria che riguarda l’Agenzia.
Misurare la qualità nel campo complesso e vario dei prodotti della conoscenza pone problemi di scelta di standard diversificati, per ambito e per approccio, disciplinare. Roberto Perotti, sul Sole 24 Ore del 30 novembre, non sembra invece nutrire dubbi che la qualità degli articoli, in economia, si misuri immediatamente e semplicemente dalla graduatoria delle riviste in cui sono pubblicati, e che il numero delle entries in un riconosciuto repertorio di scritti (l’Econlit) sia una buona misura del valore di un ricercatore o della validità di una procedura concorsuale. Ma come viene fatto il ranking delle riviste e quali sono gli articoli che vengono censiti nell’Econlit? Nonostante aggiustamenti e ponderazioni, è stabilito in base all’Impact factor, cioè il numero di volte che una rivista viene citata (paradossalmente anche per dissentire) in riviste censite dall’Intemational citation index.
Misurare la qualità nel campo complesso e vario dei prodotti della conoscenza pone problemi di scelta di standard diversificati, per ambito e per approccio, disciplinare. Roberto Perotti, sul Sole 24 Ore del 30 novembre, non sembra invece nutrire dubbi che la qualità degli articoli, in economia, si misuri immediatamente e semplicemente dalla graduatoria delle riviste in cui sono pubblicati, e che il numero delle entries in un riconosciuto repertorio di scritti (l’Econlit) sia una buona misura del valore di un ricercatore o della validità di una procedura concorsuale. Ma come viene fatto il ranking delle riviste e quali sono gli articoli che vengono censiti nell’Econlit? Nonostante aggiustamenti e ponderazioni, è stabilito in base all’Impact factor, cioè il numero di volte che una rivista viene citata (paradossalmente anche per dissentire) in riviste censite dall’Intemational citation index.
Le distorsioni di questo strumento non coinvolgono solo le scienze sociali, ma anche una disciplina non sospetta di «leggerezza» metodologica, la matematica, come ha denunciato Alessandro Figà Talamanca in più di un’occasione. Perché giuristi, storici, filosofi e letterati non nutrono altrettanta fiducia, come alcuni economisti, nella possibilità di giudicare la qualità della ricerca dal luogo di pubblicazione e dalla conta degli articoli in repertori indiscussi? Giustamente fanno notare che verrebbero sottopesati i libri, che costituiscono un genere non proprio marginale della loro produzione. Vuol dire che questi colleghi sono nemici della valutazione? O vuol dire che valutare il lavoro scientifico e di ricerca è un’attività in cui è non è indiscusso quale sia il metro e chi lo debba tenere in mano? E poi come fa a non preoccupare l’idea che il modello culturale di riferimento possa diventare unico, con buona pace del pluralismo e dell’innovazione?
Questi rilievi non devono essere interpretati come un’opposizione alla valutazione o all’impiego di metodi quantitativi per effettuarla. Anzi, proprio perché si riconosce che il sapere è per sua natura gerarchico, si vuole certezza che il riconoscimento del merito non sia unilaterale, univoco e contingente. Chi in anni passati avrebbe dato soldi a studiosi che ricercavano la spiegazione del comportamento economico nella psicologia e nelle neuroscienze? Il premio Nobel a Daniel Kahneman ha sancito l’eccellenza di una pista di ricerca che nelle riviste top altrimenti non sarebbe entrata. In altre parole, è sempre bene finanziare in base al successo di oggi, o bisogna incentivare progettualità e scommesse, magari saltando una generazione di studi? Il King’s College di Cambridge, tra le prime tre università del mondo, alcuni anni fa finanziava specificatamente temi e argomenti che, non essendo "di moda", non avrebbero trovato fondi adeguati. E’ un esempio di assunzione di responsabilità, ben diverso dalla conta degli articoli o la gara tra le pubblicazioni nelle riviste più citate, che viene oggi sbandierato per valutazione.
3 - Il Sole 24 Ore del 7 dicembre 2006
Università, il privato non è tutto
Dunque non è vero che il sistema universitario italiano è sotto finanziato e meritevole quindi di un po’ più di attenzione di quella che gli hanno riservata i decreti sulle spese intermedie del luglio scorso e la Legge finanziaria, in particolare nella sua prima versione. A mettere una volta ancora in guardia dai continui lamenti dei rettori e dalla tentazione di venire almeno in parte loro incontro, tentazione che sembra prendere corpo anche nelle aule del Senato, ci ha pensato, sul Sole 24 Ore del 30 novembre, Roberto Perotti.
Sulla "scientificità" delle sue argomentazioni è però lecito nutrire qualche dubbio. Esse si fondano su un confronto con il sistema universitario britannico, scelto perché pubblico, come il nostro. In realtà i finanziamenti alle Università inglesi derivano in maniera rilevante anche dal privato, mentre in Italia tale apporto è molto ridotto. Ma a Perotti preme fondamentalmente dimostrare che la situazione italiana è molto meno sacrificata di quanto si voglia far credere.
Un primo indicatore da lui messo in discussione è il rapportostudenti/docenti: decisamente più alto, e quindi più sfavorevole, in Italia (circa il 50% in più di quello del Regno Unito). Ma il dato non terrebbe conto del fatto che molti studenti in Italia sono fuori corso. Le statistiche in realtà adottano un correttivo, conteggiando gli studenti fuori corso (un fenomeno, ahimè, tutto nostro, almeno in quelle proporzioni) in rapporto agli esami effettivamente sostenuti. E anche Perotti arriva ad ammettere che la spesa per studente nel Regno Unito supererebbe del 20% quella italiana. Un divario "non drammatico", a suo parere: peccato che sia proprio il divario che viene indicato come la quota minima necessaria per ridare ossigeno al sistema. Rispetto a un Fondo di finanziamento ordinario di poco più di 7 miliardi, un incremento di un miliardo e mezzo avrebbe effetti non indifferenti: a condizione beninteso di misurarne bene destinazione e uso.
Ma non è su questo che verte il dissenso. Perotti non persuade neppure quando svolge il suo secondo argomento. Non solo i professori italiani non sarebbero pochi, rispetto ai loro colleghi britannici, ma non sarebbero neppure meno pagati. Perotti analizza gli stipendi medi, in entrata e, infine, al massimo della carriera, per le tre fasce di docenza: ricercatori, associati e ordinari. Egli stesso dice che l’esistenza di docenti non di ruolo non rende di facile comparabilità le due situazioni. In ogni caso riconosce che le retribuzioni d’ingresso di tutt’e tre le fasce sono inferiori in Italia; ma sostiene che da noi si progredirebbe molto più veloce, e, adducendo a riprova la retribuzione media: in effetti più elevata per il semplice motivo che l’età media dei ricercatori italiani è molto più alta di quella inglese. In Italia c’è molto meno mobilità verso la fascia più alta e quindi si rimane ricercatori più a lungo. Non sfiora il sospetto che anche questo possa essere dovuto alla mancanza di risorse e quindi al numero esiguo di posti di fascia alta e medio-alta messi a disposizione? Altrettanto può dirsi per le retribuzioni medie degli associati; mentre, per quanto riguarda gli ordinari, Perotti sa bene che, da noi, si va in pensione a 72 anni, in Inghilterra a 65.
II problema degli incentivi, all’interno di una struttura retributiva, esiste sicuramente. AL riguardo si possono concepire due forme incentivanti: quelle basate sulla progressione di carriera e quelle basate sulla remunerazione collegata all’efficacia dell’attività scientifica e didattica. Se la progressione di carriera fosse strettamente correlata all’efficacia della attività svolta, i due sistemi, qualitativamente, coinciderebbero. Affinché ciò sia vero è necessario, tuttavia, che le promozioni di carriera avvengano, se meritate, in tempi non biblici. Sono quindi essenziali cadenza e qualità dei criteri di selezione (comunque configurati).
Un’università privata (preconizzata da Perotti) è in grado di fornire, con contratti di diritto privato, gli incentivi giusti? Il problema consiste nella valutazione dell’attività. Il mercato è in grado di giudicare le attività didattiche e di ricerca meglio di quanto possa farlo un sistema di concorsi pubblici? A questo proposito nutro fortissime perplessità. L’istruzione e la ricerca sono settori nei quali esiste forte asimmetria informativa tra gli utenti (studenti) e i produttori (docenti). Secondo alcuni autori si tratta addirittura di credence goods, beni cioè per i quali è estremamente complesso, se non impossibile, misurare la qualità. In questi casi il mercato fallisce. Non si spiegherebbe altrimenti il successo, in termini di studenti iscritti, di alcune università private della cui bassissima qualità tutti noi docenti siamo convinti. Anche se si trattasse di beni di esperienza, beni, cioè, della cui qualità è possibile sincerarsi solo dopo averli provati per un po’, il costo sociale che pagherebbe la collettività (migliaia di laureati che non hanno appreso nulla e che se ne sono accorti troppo tardi) prima che si stabilisca una reputazione in grado di discriminare tra Università sarebbe altissimo. E non si adduca l’argomento che, nella situazione attuale, nel Sud solo il 4% degli studenti universitari provengono dal 20% più povero delle famiglie. E che quindi si usano le imposte dei poveri per pagare gli studi dei figli dei ricchi. Il dato è solo un riflesso di una politica del diritto allo studio del tutto inadeguata e da modificare, disponendo delle risorse indispensabili.
Anche nelle Università pubbliche esiste, beninteso, ’e va assolutamente affrontato, un problema di qualità da migliorare o da ristabilire; per questo si pone l’esigenza non più prorogabile di una valutazione seria ed efficace. Mentre non capisco perché Perotti affermi che un sistema di valutazione non sarebbe in grado di correggere le distorsioni italiane (com’è che in Gran Bretagna esso funziona?), sono d’accordo con lui quando dice che la valutazione deve essere resa efficace con quote rilevanti di premialità c/o penalizzazioni.
Perotti sa bene che l’Italia è uno dei Paesi che presenta un grado di mobilità intergenerazionale estremamente basso; sa altrettanto bene che tale valore è correlato positivamente con la quota di spesa pubblica in istruzione e con la qualità dell’istruzione stessa. Sa anche che tutti gli studi econometrici indicano invece una correlazione negativa tra il grado di mobilità intergenerazionale e la quota di spesa privata in istruzione. Vogliamo un Paese ancora più immobile dal punto di vista sociale? Perché non spingere invece su un’immediata ed efficace applicazione del sistema di valutazione auspicato dal ministero e dalla Crui?
Massimo Marrelli
ordinario di economia pubblica, Università degli Studi di Napoli Federico II
4 - Corriere della Sera del 12 dicembre 2006
Mussi attacca i rettori: rispetto per lo stato
Roma. «La sospensione degli inviti ai ministri negli atenei, annunciata ieri dai rettori italiani non può cedo essere apprezzata, e chiedo, almeno per il rispetto istituzionale reciproco dovuto, che venga revocata». Il ministro dell’Università e della ricerca Fabio Mussi ha accettato le ragioni ma non le forme della protesta decisa dal l’assemblea dei rettori (Crui).
Dopo averli richiamati alle loro responsabilità istituzionali, ha affrontato i problemi che sono dietro la rivolta. «La questione sollevata con maggior forza dal mondo universitario, quella relativa al taglio del 20 per cento dei consumi intermedi (cioè affitti, riscaldamento, pulizia, aule, ecc.) - ha detto Mussi - resta. Il governo dovrà trovare il modo di risolverla nel corso del 2007».
Contro la decisione dei rettori, che accusano la Finanziaria di togliere ossigeno agli atenei, è intervenuto il viceministro dell’Economia, Vincenzo Visco: «Un’indicazione un po’ puerile». E’ stato il primo a violare il «blocco» per gli esponenti del governo appena decretato dalla Crui: Visco ha partecipato ad un’assemblea sull’evasione fiscale organizzata dall’ateneo di Bologna dove è stato fischiato da un gruppo di studenti vicini ad An. «Se i corpi accademici e i rettori facessero un po’ di autocritica sullo stato dell’Università non farebbero male - ha dichiarato il viceministro — Certo le responsabilità sono del governo e dei politici ma se questo Paese fosse un po’meno corporativo non sarebbe male».
Intanto la linea dura dei rettori conosce le prime defezioni. L’Università di Verona ha deciso di non allinearsi. Il rettore dell’ateneo scaligero, Alessandro Mazzucco, ha invitato alla prossima inaugurazione dell’anno accademico 2006-2007 il ministro Tommaso Padoa-Schioppa, che ha accettato l’invito, anche per mostrargli da vicino i problemi dell’istituzione. «Condivido le ragioni di fondo della critica espressa dalla Conferenza dei rettori - ha spiegato Mazzucco - ma ritengo controproducenti atteggiamenti di rottura con il governo. Chi deve decidere sull’assegnazione di risorse pubbliche alle università deve prendere personalmente visione di come operano». Anche per il rettore dell’ateneo di Catania, Antonino Recca, il dialogo col governo non deve venir meno per «individuare insieme la strada che assicuri le risorse e gli strumenti necessari agli atenei.
5 - L’Altra Voce del 12 dicembre 2006
La Sardegna e le briciole per la ricerca
«Uno sforzo maggiore già dal 2007»
La Sardegna investe in sviluppo e ricerca un decimo rispetto alla media italiana - già inferiore al dato europeo - e la produttività delle sue imprese vola bassa. Rasoterra. Da ciò la minore competitività del made in Sardinia e l’alta mortalità delle aziende isolane. Con disoccupazione e bassi consumi, ovviamente, al seguito. Le cifre che riassumono questo ritardo sono state presentate ieri a Cagliari in occasione del seminario «L’industria nel futuro», organizzato dalla Confindustria Sardegna in collaborazione con la Commissione europea e dedicato al VII Programma quadro di ricerca e sviluppo comunitario. Il primo problema è la miseria investita nella ricerca e nell’innovazione: attualmente solo lo 0,04 del Pil sardo, contro lo 0,54% della media nazionale. Il presidente regionale degli industriali, Gianni Biggio, ha completato un quadro preoccupante. Ridotta produttività del lavoro: «In Sardegna 25.400 euro per addetto contro i 39.200 della Lombardia. In negativo il dato delle piccole imprese, con una produttività pari a 17.500 euro contro i 31.900 del Trentino Alto-Adige. Va un po’ meglio nel comparto manifatturiero, grazie al contributo delle grandi industrie: 35.800 euro per addetto contro i 43.200 della Lombardia. Esigua la quota delle esportazioni di beni a elevata o crescente produttività sull’export totale: nel 2005 il 13,6% rispetto al 36,3% della Lombardia».
Più cospicui gli sforzi fatti da pubblica amministrazione e Università nostrane. Nel 2004 hanno investito lo 0,63% del Pil contro lo 0,57% delle Regioni fuori dall’Obiettivo 1. Resta bassissimo il numero dei ricercatori sardi: 1,6 ogni mille abitanti, in Piemonte sono 4,3. L’anno scorso, inoltre, in Sardegna i laureati in Scienza e tecnologia erano il 6,7% sul totale, in confronto al 16,5% dell’Emilia Romagna. A parlare di titoli di studio non va meglio: al 2005 il 58,9% dei sardi fra 25 e 64 anni non possiede un diploma mentre il tasso di abbandono scolastico da noi è il più alto d’Italia. Secondo Biggio «va fatto uno sforzo straordinario innanzitutto sulla formazione preuniversitaria. Perché il numero ridotto di giovani sardi che scelgono i settori tecnicoscientifici dipende anche dall’inadeguatezza dell’insegnamento scientifico nelle scuole superiori».
Questo è il presente, per nulla roseo. E il futuro? «Nel prossimo bilancio la Regione investirà in maniera ancora più importante nella ricerca e nell’economia della conoscenza», ha promesso il presidente Renato Soru.
«Questa è l’economia di Lisbona. Abbiamo fatto delle cose importanti nella tutela del paesaggio, l’altro grande filone del pensiero europeo. La Sardegna si sta muovendo assolutamente in maniera coerente in queste due strade, tra conoscenza e ambiente». Ma attenzione all’uso delle risorse: il governatore ha richiamato il mondo accademico alla massima serietà e all’oculatezza nella destinazione dei fondi. «Nelle prossime settimane si discuterà il bilancio per il 2007, compresi gli investimenti per l’Università e quindi per l’educazione e per la ricerca universitaria. Ma siamo sicuri che i Senati accademici stiano facendo il massimo per massimizzare il valore del sistema sardo dell’Università? Siamo sicuri che non si stiano moltiplicando i corsi di laurea inutilmente? Siamo sicuri che a volte non stiamo producendo altri disoccupati solamente per fare nuovi corsi di laurea di cui non si comprende l’utilità, mentre si comprendono i costi? E quanti dei fondi per la ricerca vanno effettivamente alla ricerca migliore?». Davanti alla platea degli industriali, Renato Soru ha però allargato gli orizzonti della ricerca: «Finora abbiamo considerato la ricerca come ricerca scientifica e tecnologica e pensiamo l’economia della conoscenza come economia legata alla conoscenza scientifica. Ma la conoscenza è anche umanistica, artistica, culturale. E la ricerca deve essere fatta anche in questi ambiti, vedo grandi opportunità di ricerca e di lavoro nell’arte e nella creatività».
Roberto Mura
Roberto Mura
6 - L’Espresso del 14 dicembre 2006
Il nepotismo dilaga anche negli usa
Che fine ha fatto l’American Dream?. Le opportunità non sono più per tutti.
Ma per i figli dei ricchi: programmati fin da piccoli a emergere
Quando AIbert Gore III, figlio del candidato presidente alle elezioni del 2000, fece domanda per entrare ad Harvard, non aveva un curriculum entusiasmante. Alla high school aveva preso voti scadenti. E nella prova di accesso all’ateneo bostoniano aveva ottenuto un risultato mediocre. Ma fu ammesso. A quei tempi il padre, lui stesso laureato ad Harvard, era in corsa per la Casa Bianca, così Alhert fu preferito a migliaia di candidati con voti molto migliori. E il figlio di r Gore non è l’unico rampollo dell’America che conta ad avere avuto un trattamento in guanti bianchi nei templi della cultura. William Frist, figlio del congressista Bill, fece domanda per entrare a Princeton nel 2002, quando il padre era leader pubblicano alla Camera. Nella prova di accesso ebbe "1", il voto minimo. Migliaia di candidati che avevano avuto il massimo furono esclusi. Lui passò. Negli anni prima il padre aveva fatto donazioni per milioni di dollari a quei l’università. Daniel Golden, premio Pulirzer e giornalista del "Wall Street Journal", ha scritto un libro-inchiesta ("The Price of Admission") per raccontare come gli americani “ricchi e famosi" siano disposti a tutto pur di fare entrare gli eredi, anche quando sono perfetti asini, nelle università più quotate d’America. Essere ammessi a uno degli atenei della Ivy League garantisce da oltre tiri secolo non solo una preparazione culturale solida, ma soprattutto l’accesso a una rete di amicizie e contatti sociali che saranno la base del successo futuro. Golden sostiene che fino al 60 per cento dei posti nelle università della Ivy-league sono <assegnati ai figli di papà per ragioni che nulla hanno a che fare con il merito. Probabilmente esagera. Altri sostengono che la percentuale è tra il 25 e il 40 per cento. Nessuno nega che il problema esista e sia sempre più serio. Ci sono famiglie che elargiscono donazioni per decine di milioni di dollari, fin da quando i bimbi sono piccoli, per spianare la strada all’ammissione. Altri genitori seguono strategie più articolate. Se i pargoli non mostrano uno spiccato amore per gli studi, si decide di addestrarli a primeggiare in qualche sport, meglio se stravagante, per conquistare l’accesso grazie agli allori agonistici. Le più note università accettano un numero crescente di campioni in equitazione e canottaggio, sport diffusi soprattutto tra le élite.
Quando i genitori appartengono alla categoria dei potenti e delle "celebrities", si assiste a imbarazzanti comportamenti di servilismo. tauren Bush, top model e nipote del presidente, è stata ammessa a Princeton nonostante abhia presentato domanda un mese dopo la scadenza dei termini, e con un curriculum scadente. Il rettore dell’università ha spiegato che è stata accettata perché l’ateneo vuole «aumentare il numero di studenti non provenienti dall’elite dei liberai di sinistra». Quando la figliastra di Steven Spielberg fece domanda di iscrizione alla Duke University,il direttore andò a casa Spielberg per farle il colloquio. La ragazza fu accettata.
Quando AIbert Gore III, figlio del candidato presidente alle elezioni del 2000, fece domanda per entrare ad Harvard, non aveva un curriculum entusiasmante. Alla high school aveva preso voti scadenti. E nella prova di accesso all’ateneo bostoniano aveva ottenuto un risultato mediocre. Ma fu ammesso. A quei tempi il padre, lui stesso laureato ad Harvard, era in corsa per la Casa Bianca, così Alhert fu preferito a migliaia di candidati con voti molto migliori. E il figlio di r Gore non è l’unico rampollo dell’America che conta ad avere avuto un trattamento in guanti bianchi nei templi della cultura. William Frist, figlio del congressista Bill, fece domanda per entrare a Princeton nel 2002, quando il padre era leader pubblicano alla Camera. Nella prova di accesso ebbe "1", il voto minimo. Migliaia di candidati che avevano avuto il massimo furono esclusi. Lui passò. Negli anni prima il padre aveva fatto donazioni per milioni di dollari a quei l’università. Daniel Golden, premio Pulirzer e giornalista del "Wall Street Journal", ha scritto un libro-inchiesta ("The Price of Admission") per raccontare come gli americani “ricchi e famosi" siano disposti a tutto pur di fare entrare gli eredi, anche quando sono perfetti asini, nelle università più quotate d’America. Essere ammessi a uno degli atenei della Ivy League garantisce da oltre tiri secolo non solo una preparazione culturale solida, ma soprattutto l’accesso a una rete di amicizie e contatti sociali che saranno la base del successo futuro. Golden sostiene che fino al 60 per cento dei posti nelle università della Ivy-league sono <assegnati ai figli di papà per ragioni che nulla hanno a che fare con il merito. Probabilmente esagera. Altri sostengono che la percentuale è tra il 25 e il 40 per cento. Nessuno nega che il problema esista e sia sempre più serio. Ci sono famiglie che elargiscono donazioni per decine di milioni di dollari, fin da quando i bimbi sono piccoli, per spianare la strada all’ammissione. Altri genitori seguono strategie più articolate. Se i pargoli non mostrano uno spiccato amore per gli studi, si decide di addestrarli a primeggiare in qualche sport, meglio se stravagante, per conquistare l’accesso grazie agli allori agonistici. Le più note università accettano un numero crescente di campioni in equitazione e canottaggio, sport diffusi soprattutto tra le élite.
Quando i genitori appartengono alla categoria dei potenti e delle "celebrities", si assiste a imbarazzanti comportamenti di servilismo. tauren Bush, top model e nipote del presidente, è stata ammessa a Princeton nonostante abhia presentato domanda un mese dopo la scadenza dei termini, e con un curriculum scadente. Il rettore dell’università ha spiegato che è stata accettata perché l’ateneo vuole «aumentare il numero di studenti non provenienti dall’elite dei liberai di sinistra». Quando la figliastra di Steven Spielberg fece domanda di iscrizione alla Duke University,il direttore andò a casa Spielberg per farle il colloquio. La ragazza fu accettata.
Sulla compravendita delle ammissioni alle università più prestigiose esiste un florilegio di aneddoti. Charles Kushner, noto palazzinaro, ha versato 2 milioni e mezzo di dollari alla New York University prima dell’ammissione dei figlio Jarcd. Margarct Bass, figlia del petroliere Kohert, è entrata a Stanford dopo che il padre ha donato 25 milioni di dollari all’ateneo.
Barare in questa gara per il successo crea imbarazzo, perché è contrario alle norme fondanti della società americana. Nari come ribellione alle aristocrazie europee, gli Usa hanno iscritto nel proprio codice genetico l’amore per la meritocrazia e l’avversione verso i privilegi di casta, peculiari delle oligarchie d’oltreoceano. La Costituzione americana fu concepita, in opposizione all’Europa, partendo dal principio delle pari opportunità. I’inchiesta di Golden fa scalpore perché intacca il mito dell’American Dream, secondo cui tutti, anche con le più umili origini, possono accarezzare ogni desiderio, anche di diventare presidenti, Le statistiche raccontano un’altra storia. II reddito medio delle famiglie che mandano il figlio ad Harvard è 1 50 mila dollari all’anno. E secondo I’Educational Testing Sewicc, solo il 3 per cento degli studenti nei migliori 146 college viene da una famiglia povera (cioè dal 2.5 per cento con i redditi più bassi).
I dirigenti delle università difendono la propria libertà di scelta sostenendo che il segreto di un buon campus universitario, dove noti si studia solo ma si vive in comunità, è nel mix di studenti. Se accettassero solo i ragazzi migliori, i campus della Ivy league sarebbero posti invivibili popolati di secchioni. L’ideale è creare comunità cori studenti dagli interessi variegati, di diverse etnie e differenti ambienti socio-culturali. In teoria questi metodi di selezione dovrebbero favorire i ragazzi delle comunità nere più povere. Ma la realtà è diversa. Solo l’11 per cento di chi fa domanda è accettato, ma per i figli degli ex alunni questa percentuale sale al 40 per cento. In altri atenei, come alla Amherst University, si arriva al 10. I veri perdenti sono i giovani di origine asiatica, che primeggiano nei test, ma vengono in gran parte respinti a vantaggio dei figli delle famiglie "giuste". Jerome Karabel, professore di sociologia all’Università di California a Berkeley, ha recentemente scritto un libro, "Tbc Choscn", il prescelto. che racconta «la storia nascosta All’ammissione e dell’esclusione a Harvard, Yale e Princeton». Karahel descrive le ingiustizie commesse dagli atenei, cercando di spiegare la logica interna delle loro scelte: da una parte le classi dirigenti che premono a favore dei propri figli, dall’altra le università, spinte dalla forza naturale delle cose ad accettare l’alleanza con le classi dirigenti per mantenere il proprio primato. Noti si tratta solo di attrarre i finanziamenti dei ricchi, che così comprano una laurea importante per gli eredi, ma di un sistema di complicità che lega nei decenni le migliori università alle grandi famiglie dell’industria e della politica- E la colla di questo sistema che si autoalimenta sono i laureati, che non devono solo portare il proprio cervello, ma anche, e soprattutto, un solido nemork di relazioni familiari.
Ma non bisogna pensare che il nepotismo sia solo una rosa negativa. Versare milioni di dollari all’università è solo una tappa di una lunga corsa a ostacoli. Per le famiglie colte e benestanti la sistemazione dei figli è una delle occupazioni più importanti della vita, e richiede anni di impegno: dalla scelta dell’asilo a quella del college fino all’università. Con il tempo si è sviluppata un’articolata metodologia che negli ultimi anni ha assunto caratteristiche paradossali. Adam Bellow (figlio dello scrittore Saul) ha recentemente pubblicato un ponderoso volume ("In Praise of Nepotism", in lode del nepotismo) che racconta con dovizia di particolari questa ossessione. Bellow non parla di raccomandazioni né di donazioni. Quello che gli interessa è il "nuovo nepotismo meritocratico", basato sulla consapevolezza che il nodo migliore per favorire il successo dei figli sia la loro crescita intellettuale, ottenuta con l’acquisizione per osmosi di tutto il patrimonio culturale a cui la famiglia pub accedere e a cui i giovani sono esposti per tutta l’infanzia. Si raccontano episodi di docenti universitari che prendono un anno sabbatico per preparare i figli all’esame di ammissione universitario. Staccare un assegno da milioni di dollari è l’ultimo gesto di un percorso per addestrarci figli a primeggiare nella nuovi società della conoscenza. II neoconservatore David Brooks ha fotografato questo fenomeno in un magistrale articolo sul -New York Times", in cui finge di riscrivere un nuovo "Manifesto" in cui Karl Marx si rivolge non più ai proletari, bensì agli incolti, per invitarli alla ribellione contro i ceti intellettuali.
Osserva Brooks: - Oggi i bambini vengono trasformati in "lavoratori della conoscenza ossessionati dal lavoro, continuamente addestrati, guidati, esaminati, collaudati e preparati per rafforzare il loro dominio di classe. E alla fine, sempre per prolungare e rafforzare l’egemonia di classe, vengono mandati a Berkeley o a Yale». Che questo risultato sia ottenuto con l’addestramento alla cultura o con assegni milionari, a Brooks poco importa. Gli appartenenti a questa élite si dividono tra repubblicani e democratici che litigano su tutto eccetto che sulla fonte del loro potere: che è poi la stratificazione intellettuale della società ottenuta tramite l’istruzione. Più degli imperatori romani, più dei baroni dell’industria di rapina, i malfattori delle classi istruite non cercano solo di dominare le classi lavoratrici, ma di decimarle» E conclude: « Lavoratori poco istruiti di tutto il mondo, unitevi. Non avete da perdere che le vostre catene
7 - ll Sole 24 Ore del 14 dicembre 2006
Le priorità: merito e selezione
Quando si parla di università in Italia, si parte di solito dal presupposto che esista una ricetta in grado di risolvere la crisi, e che sia colpa soltanto delle resistenze se non si riesce ad applicarla. Quanto questa visione sia fuorviante mi è stato confermato da un incontro organizzato a Roma dal Cersdu, un centro di ricerca, da me diretto, dell’Università Luiss "Guido Carli", al quale erano presenti studiosi che hanno dato contributi significativi, come Alessandro Figà Talamananca, Raffaele Sirnone, Marco Santambrogio, Dario Antiseri, Massimo Egidi, Alessandro Ferrara. Molte le proposte interessanti: suddivisione delle università in diversi livelli, come università di studio e di ricerca; abolizione del valore legale del titolo di studio; riforma dell’edilizia universitaria; radicale cambiamento delle norme dei concorsi; riduzione del numero degli atenei; necessità di affidarsi solo parzialmente agli indici accademici internazionali; riqualificazione degli incentivi materiali e culturali e così via. Ma queste proposte non sono state in grado di configurare una soluzione unitaria.
Resistendo quindi alla tentazione di lanciare un’ulteriore proposta di sostanza, mi limito qui a formularne una di metodo: prima di adottare qualunque soluzione, dobbiamo informare il pubblico sui meriti relativi delle varie università, attraverso un processo di valutazione comparativa, identificando i soggetti interessati (gli stakeholder) e i criteri di valutazione.
Gli stakeholder sono innanzitutto le università - se separiamo l’istituzione in quanto tale dal corpo docente e dagli studenti - é poi tutti gli enti che hanno rapporti con il mondo universitario: il mondo del lavoro, i finanziatori della ricerca, i media, le istituzioni culturali, amministrative e politiche. La valutazione comparativa giova a tutti, perché consente di scegliere a ragion veduta. Per esempio nel caso dei finanziatori potenziali.
Più complicato è orientarsi sui criteri di valutazione. Un criterio, per così dire, esterno, consiste nelle cifre dei bilanci. Quali sono i costi e i ricavi di un ateneo? Sempre più, però, i bilanci economici dovranno essere accompagnati dai bilanci sociali, i quali offrono una fotografia delle attività accademiche, in cui costi e ricavi sono commisurati a scopi più ampi di quelli puramente economico-finanziari. Le attività riguardano da un lato i servizi offerti agli studenti e ai professori, le forme di collaborazione con altre università, anche straniere, il sostegno offerto alla ricerca; dall’altro le strutture di supporto, come le aule, le biblioteche e i laboratori, l’amministrazione, il controllo di gestione e così via.
Più complicato è orientarsi sui criteri di valutazione. Un criterio, per così dire, esterno, consiste nelle cifre dei bilanci. Quali sono i costi e i ricavi di un ateneo? Sempre più, però, i bilanci economici dovranno essere accompagnati dai bilanci sociali, i quali offrono una fotografia delle attività accademiche, in cui costi e ricavi sono commisurati a scopi più ampi di quelli puramente economico-finanziari. Le attività riguardano da un lato i servizi offerti agli studenti e ai professori, le forme di collaborazione con altre università, anche straniere, il sostegno offerto alla ricerca; dall’altro le strutture di supporto, come le aule, le biblioteche e i laboratori, l’amministrazione, il controllo di gestione e così via.
A questo punto iniziano le vere difficoltà del processo di valutazione comparativa, cioè i pesi da attribuire ai criteri di valutazione e alla volontà degli stakeholder. È qui che entrano in gioco visioni teoriche diverse e interessi contrastanti.
Ai professori interessano le possibilità di fare ricerca, i semestri o gli anni sabbatici pagati, i contatti internazionali, il potere di avere consulenze, e così via. Agli studenti interessa ricevere un buon insegnamento, rafforzato dal prestigio dell’università da cui provengono. Ma, se gli studenti dei primi anni chiedono soprattutto docenti scrupolosi, quelli più avanti negli studi sono maggiormente interessati alle opportunità di ricerca e ai contatti con l’accademia straniera, e quelli in uscita desiderano soprattutto trovare un’occupazione.
Al mondo del lavoro interessa assumere studenti preparati e capaci d’innovazione, ma anche sostenere determinati indirizzi, offrendo borse di studio in settori specifici. A tutti però, almeno in teoria, dovrebbe stare a cuore che l’università metta da parte un falso egualitarismo e crei selezione: un mondo in cui le istituzioni accademiche non selezionano è un mondo in cui i rapporti famigliari e clientelari decidono al posto dei meriti.
Al mondo del lavoro interessa assumere studenti preparati e capaci d’innovazione, ma anche sostenere determinati indirizzi, offrendo borse di studio in settori specifici. A tutti però, almeno in teoria, dovrebbe stare a cuore che l’università metta da parte un falso egualitarismo e crei selezione: un mondo in cui le istituzioni accademiche non selezionano è un mondo in cui i rapporti famigliari e clientelari decidono al posto dei meriti.
Sebastiano Maffettone
8 - Corriere della Sera del 15 dicembre 2006
La protesta dei rettori: atenei chiusi ai ministri
Rivolta contro la finanziaria. «Posti solo in platea a inaugurazioni e cerimonie ufficiali»
Roma. Vietato invitare i membri del governo a presenziare alle inaugurazioni dell’anno accademico, alle celebrazioni di illustri studiosi, alle lauree ad honorem e a tutte le più significative cerimonie organizzate dagli atenei. Ministri e sottosegretari, anche se colleghi, potranno accomodarsi in platea, non al tavolo delle autorità accademiche. L’inclusione di ministri in carica in un elenco di persone sgradite, con Fabio Mussi inevitabilmente al primo posto, è stata decisa dall’assemblea dei rettori (Crui).
I RETTORI — È la risposta alla Finanziaria che «minaccia la sopravvivenza » dei 75 atenei del Paese. In un clima molto acceso, quasi di rivolta nei confronti dell’esecutivo - si è parlato di sciopero fiscale, di dimissioni in massa, di azioni legali -, i rettori hanno espresso un giudizio di durissima condanna nei confronti della manovra. Un governo che punisce l’università, che crea dif- ficoltà insormontabili nella vita quotidiana degli atenei, hanno decretato i rettori, non è più il benvenuto nelle nostre aule. Si tratta di una sorta di espulsione da un mondo, quello universitario, che si aspettava dal governo di centrosinistra una valorizzazione e che quasi non riesce a credere alle cifre della Finanziaria. «Eravamo coscienti del momento difficile - ha dichiarato il presidente dell’assemblea, Guido Trombetti, rettore della "Federico II" di Napoli - avevamo chiesto di fare sacrifici ma di avere garantita la sopravvivenza. Invece così non si garantisce nulla. Soprattutto non si garantisce il diritto allo studio degli studenti, protetto dalla Costituzione, perché sono diminuiti anche i fondi per le borse di studio. Per questi motivi l’università - che resta un luogo aperto a tutti - non inviterà i membri di questo governo».
I TAGLI — Anche nel 2007 il decreto Bersani imporrà agli atenei tagli alle spese riguardanti la gestione ordinaria: affitti, utenze, pulizie, riscaldamento, abbonamento alle riviste e via dicendo. Le somme dovranno essere ridotte del 20 per cento rispetto alle previsioni. Secondo i rettori i tagli si aggirano sui 200 milioni di euro. Il fondo di finanziamento ordinario, che serve per pagare gli stipendi - ma non gli aumenti automatici che sono a carico delle singole università e ammontano a circa 150 milioni di euro l’anno -, è cresciuto di poche decine di milioni. La protesta dei rettori, mai così dura, punta ad evitare il collasso degli atenei che nei prossimi mesi potrebbero non avere i soldi per pagare l’affitto, gli abbonamenti alle riviste e le bollette della luce. L’obiettivo è liberare l’università dal peso del decreto Bersani prima che si concluda l’iter della Finanziaria. Nessun commento da parte del ministro Fabio Mussi, che ha minacciato le dimissioni se saranno confermati i tagli all’università apparsi nella prima stesura della manovra. Il silenzio del ministro rivela forse un estremo tentativo per trovare una soluzione.
I COMMENTI — La decisione dei rettori fa discutere maggioranza e opposizione. Giuseppe Valditara, An: «Per l’università è arrivata la clamorosa presa in giro. Paradossalmente la cosa più negativa è che non si intravede un’evoluzione positiva dato che si prevedono tagli ancora maggiori - oltre 200 milioni di euro - per il 2008». Andrea Ranieri, Ds, riconosce che «nella Finanziaria non si è tenuto conto delle difficoltà in cui versano le università italiane». «Una soluzione - ha proposto l’esponente Ds - potrebbe venire dal prossimo varo dell’Agenzia di valutazione, se riusciremo a dotarla delle risorse necessarie per assegnare finanziamenti agli atenei, premiando il merito delle strutture, dei docenti e degli studenti ». Matteo Renzi, della Margherita, punta il dito su un’apparente contraddizione dei docenti universitari. «Trovo esagerata ed ingiusta l’inaudita forma di protesta decisa dalla Conferenza dei rettori - ha dichiarato Renzi -. Se davvero si hanno a cuore le sorti dell’università, perché puntare il dito soltanto sull’esecutivo? Perché non andare a guardare, per esempio, cosa fanno e cosa hanno fatto alla Camera o al Senato i docenti e i rettori universitari una volta divenuti parlamentari?».
I RETTORI — È la risposta alla Finanziaria che «minaccia la sopravvivenza » dei 75 atenei del Paese. In un clima molto acceso, quasi di rivolta nei confronti dell’esecutivo - si è parlato di sciopero fiscale, di dimissioni in massa, di azioni legali -, i rettori hanno espresso un giudizio di durissima condanna nei confronti della manovra. Un governo che punisce l’università, che crea dif- ficoltà insormontabili nella vita quotidiana degli atenei, hanno decretato i rettori, non è più il benvenuto nelle nostre aule. Si tratta di una sorta di espulsione da un mondo, quello universitario, che si aspettava dal governo di centrosinistra una valorizzazione e che quasi non riesce a credere alle cifre della Finanziaria. «Eravamo coscienti del momento difficile - ha dichiarato il presidente dell’assemblea, Guido Trombetti, rettore della "Federico II" di Napoli - avevamo chiesto di fare sacrifici ma di avere garantita la sopravvivenza. Invece così non si garantisce nulla. Soprattutto non si garantisce il diritto allo studio degli studenti, protetto dalla Costituzione, perché sono diminuiti anche i fondi per le borse di studio. Per questi motivi l’università - che resta un luogo aperto a tutti - non inviterà i membri di questo governo».
I TAGLI — Anche nel 2007 il decreto Bersani imporrà agli atenei tagli alle spese riguardanti la gestione ordinaria: affitti, utenze, pulizie, riscaldamento, abbonamento alle riviste e via dicendo. Le somme dovranno essere ridotte del 20 per cento rispetto alle previsioni. Secondo i rettori i tagli si aggirano sui 200 milioni di euro. Il fondo di finanziamento ordinario, che serve per pagare gli stipendi - ma non gli aumenti automatici che sono a carico delle singole università e ammontano a circa 150 milioni di euro l’anno -, è cresciuto di poche decine di milioni. La protesta dei rettori, mai così dura, punta ad evitare il collasso degli atenei che nei prossimi mesi potrebbero non avere i soldi per pagare l’affitto, gli abbonamenti alle riviste e le bollette della luce. L’obiettivo è liberare l’università dal peso del decreto Bersani prima che si concluda l’iter della Finanziaria. Nessun commento da parte del ministro Fabio Mussi, che ha minacciato le dimissioni se saranno confermati i tagli all’università apparsi nella prima stesura della manovra. Il silenzio del ministro rivela forse un estremo tentativo per trovare una soluzione.
I COMMENTI — La decisione dei rettori fa discutere maggioranza e opposizione. Giuseppe Valditara, An: «Per l’università è arrivata la clamorosa presa in giro. Paradossalmente la cosa più negativa è che non si intravede un’evoluzione positiva dato che si prevedono tagli ancora maggiori - oltre 200 milioni di euro - per il 2008». Andrea Ranieri, Ds, riconosce che «nella Finanziaria non si è tenuto conto delle difficoltà in cui versano le università italiane». «Una soluzione - ha proposto l’esponente Ds - potrebbe venire dal prossimo varo dell’Agenzia di valutazione, se riusciremo a dotarla delle risorse necessarie per assegnare finanziamenti agli atenei, premiando il merito delle strutture, dei docenti e degli studenti ». Matteo Renzi, della Margherita, punta il dito su un’apparente contraddizione dei docenti universitari. «Trovo esagerata ed ingiusta l’inaudita forma di protesta decisa dalla Conferenza dei rettori - ha dichiarato Renzi -. Se davvero si hanno a cuore le sorti dell’università, perché puntare il dito soltanto sull’esecutivo? Perché non andare a guardare, per esempio, cosa fanno e cosa hanno fatto alla Camera o al Senato i docenti e i rettori universitari una volta divenuti parlamentari?».
9 - Corriere della Sera del 15 dicembre 2006
Il girotondo dei rettori
Le minacce, no, non ce le saremmo aspettate dalla Conferenza dei rettori italiani. La protesta per le risorse negate all’Università dalla Finanziaria è legittima. Il grido d’allarme sullo stato comatoso dei bilanci universitari, lo sconcerto per l’ insensibilità dimostrata nei confronti della ricerca: tutto questo è meritevole di considerazione e la maggioranza di governo farebbe male a non tenerne conto. Ma se i rettori decidono di svestirsi del loro ruolo togato e arrivano a intimare ai rappresentanti del governo di tenersi lontani dalle «significative manifestazioni in Università», è un lessico inaccettabile quello che traspare dalle loro dichiarazioni. Il governo dovrà naturalmente tener conto degli argomenti di chi teme una penalizzazione eccessiva delle Università. E il comunicato dei rettori, così virulento nei toni e nelle parole, sancisce una rottura simbolica la cui portata è paragonabile ai fischi operai di Mirafiori. Era stato infatti il centrosinistra ad appoggiare la protesta del mondo universitario contro il governo di centrodestra. «Ricerca» e «istruzione» sono state due parole chiave nella polemica dell’ Unione contro una maggioranza, quella che sosteneva la compagine governativa guidata da Berlusconi, accusata di abbandonare alla deriva un universo vitale per il futuro dell’ Italia. Ai rettori, vezzeggiati e assecondati per cinque anni, sono state offerte candidature alle elezioni. Il Magnifico Rettore dell’Università di Reggio Calabria, Alessandro Bianchi, è diventato ministro. Se ora i rettori si sentono traditi e percepiscono una sordità del governo sui temi della ricerca e dell’ istruzione, il governo deve fare un esame di coscienza. I fischi e le contestazioni al governo, se si eccettua qualche sbavatura e caduta di stile, possono anche essere uno stimolo a cambiare, un modo per esprimere delusione per chi, anziché avvitarsi in dispute nominalistiche su ciò che si dovrà fare dopo la Finanziaria, deve fare subito tesoro degli errori commessi. Ma davvero c’è bisogno di un ennesimo girotondo, nientemeno che di un girotondo dei rettori che stona in modo così stridente con la loro funzione e la loro immagine austera? Se la spaccatura tra il mondo della ricerca e il governo è dunque un campanello d’allarme per chi ha varato una Finanziaria al di sotto delle aspettative dei rettori e dei ricercatori dell’Università, le forme e i modi della protesta non sono indifferenti, anche se lo scopo può essere condivisibile. Il metodo dell’ultimatum, l’invito ai membri del governo a non mettere piede all’Università sono appunto forme che i rettori, per la delicatezza del loro ruolo e per il carattere in un certo senso istituzionale della loro funzione, devono saper arginare per non far cadere l’Italia in una deriva caotica e civilmente disgregata che in altri tempi si sarebbe detta «sudamericana». I rettori invitino il governo nelle Università, chiedano conto delle promesse non mantenute, ripetano quanto hanno detto nella passata legislatura, e cioè che una nazione moderna non può permettersi di mortificare la ricerca. Ma evitino i girotondi. Non per risparmiare critiche al governo. Ma per risparmiare all’ Italia l’ennesima brutta figura.

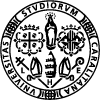 Università degli Studi di Cagliari
Università degli Studi di Cagliari
