Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali
PREMESSA
La tesi qualifica il percorso formativo dello studente ed è il risultato di un’attività di ricerca, svolta sotto la guida di un docente relatore, su un tema riconducibile alle discipline che caratterizzano il curriculum dello studente. Può trarre spunto da un’esperienza di lavoro (stage) o di studio in Italia o all’estero. Nella tesi lo studente deve dimostrare padronanza delle basi metodologiche degli ambiti disciplinari rilevanti e deve approfondire un argomento specifico sviluppando, in modo originale, aspetti teorici o aspetti applicativi e di natura empirica.
Scelta dell’argomento e definizione della domanda di ricerca
La scelta dell’argomento della tesi e delle connesse domande di ricerca rappresenta un passo fondamentale nel garantire la qualità del lavoro svolto. Il problema non consiste tanto nel trovare un argomento su cui scrivere (“di che cosa voglio parlare nella mia tesi?”). Piuttosto, il problema consiste nell’elaborare una o più domande di ricerca interessanti cui rispondere (“che cosa, in particolare, voglio capire attraverso il mio studio?”; “quali domande è interessante porsi sull’argomento che ho scelto, e in che modo queste sono connesse tra loro?”).
Formulare una o più domande di ricerca connesse all’argomento prescelto significa:
• definire con precisione quali sono i confini dell’argomento che si è scelto;
• identificare gli aspetti dell’argomento scelto sui quali si intende concentrare l’attenzione;
• interrogarsi sulla effettiva rilevanza, in termini teorici o pratici, del tema di ricerca prescelto.
Impostazione della tesi
Definire il piano di ricerca della tesi significa rispondere alle seguenti domande:
In che modo lo studio verrà condotto, in concreto?
Quali approcci, quali metodi e tecniche verranno utilizzati per raccogliere e analizzare i dati?
Quali criteri verranno impiegati per garantire validità alla tesi?
Che cosa potrebbe far sì che le conclusioni siano sbagliate? In che modo si cercherà di aggirare le minacce alla validità dello studio?
In che modo questi elementi costituiscono una “strategia” coerente in grado di condurre dalle domande di ricerca alle conclusioni della tesi?
Le possibili risposte a queste domande e la scelta di quelle più adatte alla propria tesi variano a seconda della disciplina di riferimento e delle domande di ricerca. L’attenta analisi della letteratura di riferimento e l’interazione con il relatore consentiranno di fare le scelte più corrette. Tuttavia, alcuni elementi del disegno di ricerca devono generalmente essere definiti, se si vuole che la tesi sia chiara e rigorosa.
La ricerca bibliografica
Lo svolgimento di un’accurata ricerca e analisi della letteratura di riferimento è parte integrante e ineliminabile del lavoro di tesi. Essa consente di raggiungere almeno due obiettivi di fondo, in due fasi distinte: ? in una fase preliminare (generazione delle domande di ricerca), essa consente di sviluppare domande di ricerca interessanti e innovative connesse all’argomento prescelto; ? in una fase successiva – quando cioè la domanda/e di ricerca è già stata individuata – la ricerca bibliografica consente di capire come la tesi si posiziona nell’ambito del sapere esistente sui quesiti di ricerca sollevati. In tal modo, l’analisi della letteratura consente di verificare se la domanda/e di ricerca individuata sono davvero valide e interessanti e, in caso contrario, di modificarle o affinarle.
Nel compiere la ricerca e l’analisi della letteratura di riferimento lo studente deve quindi porsi continuamente le seguenti domande:
Quali sono i contributi più importanti all’interno della letteratura sull’argomento?
Questi contributi possono fornire spunti validi per la elaborazione e per la illustrazione critica dell’argomento oggetto della tesi?
Suggeriscono risposte o idee in linea con gli assunti sostenuti nel testo? In caso contrario, di essi dovrà essere dato conto in modo critico nel testo o nell’apparato delle note e, nei casi estremi, dovranno indurre a riconsiderare la validità degli assunti del testo. Se gli autori hanno verificato la coerenza delle loro risposte, in che modo l’hanno fatto?
Vi sono nella letteratura esistente dei “gap” in termini di domande di ricerca senza risposta, di ambiti empirici non esplorati, di conflitti non risolti tra studi che giungono a conclusioni opposte?
Quale “gap” di conoscenza mira a colmare la mia tesi?
Quale tipo di approccio/modello può essere utile per rispondere ai quesiti di ricerca sollevati?
La ricerca bibliografica dovrebbe spaziare su una tipologia ampia di fonti italiane e internazionali. Si ricorda che la Biblioteca mette a disposizione numerose fonti, tra le quali si segnalano, oltre ai libri:
- riviste in formato cartaceo e su supporto elettronico;
- banche dati (alcune delle quali contenenti a loro volta numerose riviste). Link https://sba.unica.it/risorse-digitali/banche-dati
La redazione definitiva
La redazione definitiva comporta la stesura dell’elaborato di tesi secondo le indicazioni riportate nelle regole di Ateneo. La struttura della tesi, in relazione alle specifiche esigenze proprie dell’argomento prescelto, sarà sottoposta all’esame del Docente di riferimento, che fornirà ogni indicazione ritenuta opportuna.
In linea di massima la tesi si compone di un indice, di una introduzione, della vera e propria trattazione articolata in capitoli, della conclusione e delle bibliografia. Nell’Abstract è offerta una sintesi, solitamente di circa 250 parole, dell’argomento della tesi, della struttura argomentativa e metodologica del lavoro e delle principali conclusioni raggiunte.

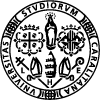 Università degli Studi di Cagliari
Università degli Studi di Cagliari

