Dipartimento di Giurisprudenza
1.— Impostazione generale del lavoro
L'assegnazione della tesi pressuppone il superamento dell'esame,
se necessario sarà accordata preferenza agli studenti frequentanti.
Con l’assegnazione dell’argomento saranno
indicate allo studente le prime opere da consultare per l’avviamento della ricerca.
Acquisita una buona conoscenza del tema, questi dovrà presentare il repertorio
sistematico delle opere esaminate e della giurisprudenza, unitamente alla proposta di
ripartizione della trattazione in capitoli e paragrafi (schema della tesi).
L’approvazione del repertorio e dello schema costituiscono condizioni indispensabili per
poter procedere alla stesura.
Il lavoro, nella sua versione definitiva, completo di una breve premessa, dell’indice, della
bibliografia (elenco dei testi consultati) e della giurisprudenza (elenco cronologico delle
sentenze citate) dovrà essere consegnato tassativamente entro 20 giorni dalla scadenza del
termine indicato per il deposito presso gli uffici di segreteria.
2.— Impostazione del testo
Il lavoro dovrà essere articolato in capitoli (da indicarsi con numeri romani) e paragrafi
(da indicarsi con numeri arabi). A ciascun paragrafo dovrà, inoltre, essere assegnato un titolo
(da indicarsi in corsivo).
Esempio:
3. Elementi tipici e soggetti del soccorso. Oppure 4.— La questione del liability salvage.
Qualora i paragrafi fossero molto numerosi sarebbe preferibile collocare, all’inizio di ciascun
capitolo, un sommario indicante numero e titolo degli stessi.
Esempio:
SOMMARIO — 1. Introduzione — 2. La liberalizzazione del trasporto aereo in Europa: un’occasione
(parzialmente) perduta — 3. Gli interventi correttivi previsti nel reg. (CEE) n. 2408/92 — 4. La svolta operata dalla legge n. 144/1999 — 5. La procedura di imposizione degli oneri di servizio pubblico — 7. La gara d’appalto — 8. Brevi accenni sugli aiuti sociali.
3.— Elaborazione del testo
È vivamente consigliato di dare inizio alla stesura del lavoro soltanto dopo aver acquisito
una buona conoscenza dell’argomento attraverso un congruo numero di letture.
È auspicabile, inoltre, servirsi di periodi il più possibile brevi ed intellegibili, di avvalersi
delle citazioni testuali solo quando veramente indispensabili.
La tesi di laurea consiste in un elaborato personale, e il laureando deve avere cura di
citare nelle note a pié di pagina le fonti (gli autori e il luogo di pubblicazione) da cui ha tratto
le argomentazioni utilizzate.
Si raccomanda di citare solo i testi effettivamente consultati evitando riferimenti inutili o
ridondanti (esempio: una monografia del secolo scorso concernente profili del tutto secondari
dell’argomento). E' consentito riportare integralmente il pensiero di altri autori
quando si tratti di passi particolarmente significativi.
In tal caso la frase deve essere racchiusa tra virgolette, che
devono essere indicate utilizzando il seguente carattere <<… >>. Il virgolettato alto (“…”)
deve essere usato soltanto nei casi di citazione all’interno di un periodo già virgolettato.
Il corsivo deve essere utilizzato soltanto per i nomi comuni in lingua straniera, compreso
il latino, eccettuate le parole di uso comunissimo. La parola container, per esempio, deve
preferibilmente essere scritta in tondo.
Qualora, nel riportare un brano di altro testo, siano omessi dei passi, dovranno essere
impiegati i tre puntini di sospensione racchiusi fra parentesi quadre: […]; tuttavia
l’omissione, quando relativa esclusivamente all'inizio o il termine del periodo, non deve
essere segnalata.
Fra le parole va collocato un solo spazio (una sola battuta di barra spaziatrice).
Dopo ciascun punto e ciascuna virgola occorre sempre uno spazio.
L’apostrofo non richiede mai lo spazio.
Se la frase termina con una abbreviazione puntata, non occorre aggiungere un altro punto.
4.— Note a piè di pagina
Gli esponenti di nota devono sempre essere indicati con numeri ordinari e, all’interno del
corpo della nota, non si va mai a capo. La prima riga di ogni nota deve essere rientrata di
circa un centimetro verso l’interno della pagina.
Esempio:
Sulla materia degli aiuti di Stato a finalità regionale v.
M. ATZWANGER, Gli aiuti erogati da enti territoriali in Italia, in Foro pad.1995, II, 34;
V. CAMPOGRANDE, Gli aiuti a finalità regionale in Italia, in Riv. dir. eur. 1995, I, 53.
4.a — Citazioni della legislazione.
Il tipo ti atto normativo deve sempre essere abbreviato, segue la data (per esteso) e il
numero. Non occorre la virgola fra la data ed il numero, né dopo il numero dell’articolo (a
meno che non si debba indicare il comma).
La parola comma non si abbrevia mai.
Esempio:
Art. 16 della l. 28 gennaio 1994 n. 84.
Art 16, quarto comma, l. 28 gennaio 1994 n. 84.
Art 16, comma 4, lettera a, l. 28 gennaio 1994 n. 84.
Art. 1 reg. (CEE) n. 4056/86 del 22 dicembre 1986.
Art. 1 dir. 95/64/CE dell’8 dicembre 1995.
4.b — Citazioni della giurisprudenza.
L’organo giudicante, da indicare in tondo anche se straniero,
deve sempre essere abbreviato. Segue la data della sentenza
(da indicarsi per esteso) il numero, una virgola,
l’indicazione del luogo di pubblicazione (in corsivo) che deve essere fatto precedere dalla
preposizione <<in>>.
Non occorre, invece, la virgola fra l’organo giudicante e la data della sentenza, né fra la data
e il numero, né fra la rivista e l’anno. Per la Cassazione non è necessario indicare la sezione
eccetto <<sez. un.>>; Per la Cassazione penale non occorre il numero quando è indicato il luogo di pubblicazione.
Esempio:
App. Torino 3 luglio 1991, in Dir. trasp. 1993, 89.
Cass. 14 ottobre 1991 n. 10763, in Dir. trasp. 1993, 847.
Cons. St., sez. VI, 29 aprile 1989 n. 531, in Dir. trasp. 1996, 489.
Dovendo citare la stessa sentenza più di una volta può evitarsi di ripetere il luogo di
pubblicazione sostituendolo con <<cit.>>.
Esempio:
Cass. 14 ottobre 1991 n. 10768, cit.
La giurisprudenza dei paesi di common low si cita secondo l’uso con l’indicazione del
nome delle parti fra l’abbreviazione << v.>> tutto in corsivo.
Segue l’indicazione del luogo di pubblicazione, in tondo.
Esempio:
Adamastos Shipping v. Anglo-Saxon Petroleum [1958] 1 Lloyd’s Rep. 73.
4.c — Citazioni della dottrina.
Il cognome dell’autore deve essere scritto in carattere <<MAIUSCOLO>>
o <<MAIUSCOLETTO>>ed è vivamente
raccomandata l’indicazione dell’iniziale puntata del nome, a precedere il cognome. Nel caso
di opere scritte a più mani i nomi dei coautori devono essere separati da un trattino breve.
Per le monografie al nome dell’autore seguono, separati dalle virgole: il numero del volume
o del tomo (in numeri romani senza <<vol>>.), il numero dell’edizione (in numeri romani), la
città sede principale della casa editrice, l’anno di edizione, il numero di pagina non preceduto
da p. o pag.
Esempio:
M. DEIANA, I liens nei contratti di utilizzazione della nave, Torino, 1995.
Per gli articoli delle riviste, dopo il titolo in corsivo e una virgola,
segue la preposizione <<in>>, poi l’abbreviazione in corsivo del nome della rivista.
Seguono la data e il numero della pagina non preceduto da <<p.>>.
Fra il nome della rivista e la data non occorre la virgola.
Esempio:
M. PIRAS, L’assicurazione della responsabilità del vettore aereo di persone,
in Dir. trasp. 2001, 461 ss.
L. ANCIS, Sulla natura dei servizi di sicurezza aggiuntivi in ambito aeroportuale
(nota a Cons. St., sez. VI maggio 2000 n. 2876) in Dir. trasp. 2001, 123 ss.
Per le enciclopedie è sufficiente indicare il volume e l’anno di edizione, separati da una
barra.
Esempio:
L. TULLIO, Lettera di trasporto aereo, in Dig. Comm. VIII/1992, 558.
Se si vogliono citare diverse pagine dello stesso brano l’indicazione del numero di pagina
deve essere fatta seguire da <<ss>> non preceduta da virgole. Nel caso in cui la stessa opera sia
citata diverse volte è possibile limitarsi ad indicare l’autore e titolo dell’opera, seguiti (fra
due virgole) da op. cit., cit. oppure op. ult. cit.

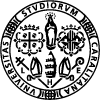 University of Cagliari
University of Cagliari
