ufficio stampa e redazione web: rassegna quotidiani locali
05 December 2006
R A S S E G N A W E B
del 5 dicembre 2006
Di seguito 12 articoli pubblicati nell’ultima settimana, dal 25 novembre 2006, sulle testate: Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, La Repubblica, Il Manifesto, Europa
1 - Corriere della Sera del 25 novembre 2006
Caro laureato
Novanta milioni per un ingegnere
Novanta milioni per un ingegnere
La formazione universitaria costa cara allo Stato : una ventina di milioni all’anno per ogni studente
Novanta milioni per creare un ingegnere, 60 per un laureato in giurisprudenza e quasi 45 per un diplomato. La formazione universitaria costa cara allo Stato: una ventina di milioni all’ anno per ogni studente.
Anche il Cun ha posto attenzione ai costi, nell’ elaborare il piano delle facoltà di ingegneria, e da quest’ anno punterà sul recupero di efficienza degli atenei lombardi. Intanto, dalle prossime settimane decollerà il programma di coordinamento regionale delle diverse facoltà. Le ultime cifre sulle iscrizioni evidenziano un incremento per le facoltà scientifiche e una flessione per quelle letterarie. "Negli ultimi tre anni il numero delle immatricolazioni e’ aumentato oltre le previsioni, sia nella sede centrale sia in quelle periferiche", ha detto il professor Marcello Fontanesi, preside di Scienze all’ Università degli studi di Milano, con gemmazione di corsi (Fisica, Chimica e Matematica) a Como, intervenendo al convegno "Università : sviluppo, cooperazione e risorse", svoltosi nei giorni scorsi al casinò di Campione. Al simposio hanno partecipato, oltre ad Antonio Ruberti, già ministro dell’ Università e della Ricerca scientifica, i rettori degli atenei di Milano, Pavia e Brescia.
V.D.C.
2 - Il Sole 24 Ore del 27 novembre 2006
Ai concorsi non vinca il migliore
Quattro idonei su 32 chiamati da università diverse da quella che ha indetto il concorso o non rappresentata in commissione. Ben 15 idonei con pubblicazioni solo dalla 161 rivista in poi (secondo il ranking di EconLit, un database di pubblicazioni accademiche on line), tre soltanto dalla 71a in poi, mentre 14 hanno almeno una pubblicazione nelle prime 70. Addirittura uno dei candidati non ha pubblicazioni su riviste straniere refereed. Questi risultati riguardano l’ultima tornata concorsuale per professore ordinario nei tre settori scientifici attinenti all’economia, iniziata nel 2003-2004 e conclusasi quest’anno. I dati sono contenuti nell’ultimo Bollettino dei concorsi che curo periodicamente. Per ogni concorso (in questo caso 16) il Bollettino considera le pubblicazioni di ogni candidato e di ogni commissario, oltre a varie indicazioni biografiche. Il Bollettino è consultabile su www.igier.uni-bocconi.it/perotti. Altre informazioni elaborate nell’ultimo Bollettino: 14 dei 32 idonei sono candidati interni. Di essi, nove hanno pubblicazioni EconLit solo dalla 161 in poi. Riguardo ai professori esaminatori, nelle 16 commissioni sette hanno un totale di zero pubblicazioni tra le prime 70 EconLit e uno ha zero pubblicazioni nelle prime 160. Per valutare questi dati in prospettiva, è importante notare che le discipline economiche sono in qualche misura un’isola felice nel panorama universitario italiano (insieme ad altre discipline formalizzate come fisica, matematica, ingegneria) perché essendo molto internazionalizzate si prestano a un minimo di controllo sulla qualità della produzione scientifica.
Inoltre, questi dati ovviamente possono dire poco sulla pratica dei concorsi. Alcuni concorsi hanno tre o quattro candidati per due idoneità, perché è già noto a tutti che i candidati interni vinceranno. In certi concorsi, alcuni candidati vengono dissuasi (magari con qualche telefonata "amichevole") dal presentarsi, per non rovinare la festa altri candidati vengono obbligati a presentarsi, anche se non hanno alcuna speranza, per salvare le apparenze dl un concorso serio, in cambio della promessa di un appoggio in futuro.
Un’analisi econometrica di 40 concorsi negli stessi tre settori di scienze economiche è contenuta nel mio lavoro The Italian University System: Rutes vs. Incentives (scaricabile da www.igier.uni-bocconi.it/perotti). II lavoro mostra fra l’altro che, in media, essere un insider nell’università che ha indetto il concorso aumenta la probabilità di ottenere l’idoneità nella stessa misura di 13 pubblicazioni in riviste internazionali sottoposte al vaglio della professione (riviste refereed). Conclusione: i concorsi sono irriformabili.
3 - Il Riformista del 28 novembre 2006
I limiti dell’agenzia ministeriale
Sull’università il Governo affonda la meritocrazia
L’onorevole Walter Tocci, responsabile Ds per Ricerca e università, ha rassegnato le sue dimissioni perché il «risultato» della manovra è «insoddisfacente» nel campo di sua competenza, non solo e non tanto perché nella finanziaria «permangono tagli agli enti di ricerca e all’università», quanto soprattutto perché «la parte normativa è inadeguata... L’istituzione dell’apposita Agenzia per la valutazione è ancora una semplice aggiunta al vecchio sistema burocratico e non è ancora assunta come la leva fondamentale per riformarlo... La strada del merito non solo sarebbe la più adatta a governare lo specifico della ricerca, ma sarebbe anche la più semplice da attuare». Pur tra le molte differenze, questa impostazione è condivisa da numerosi, autorevoli professori universitari: per citarne uno, Francesco Giavazzi sostiene sul Corriere della sera del 14 novembre 2006 che se davvero volesse spostare i fondi per la ricerca «dalla mediocrità all’eccellenza... il ministro Mussi avrebbe un modo semplice per dimostrarlo: assegni una quota significativa delle risorse in base alle valutazioni che il suo stesso ministero tramite il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (Civr) ha appena svolto. Da quest’anno accademico, non "in futuro" come invece ha annunciato».
Le parole chiave Civr e Agenzia richiedono un approfondimento. Con il decreto n. 2206 del dicembre 2003, il ministro Moratti affida al Civr il compito di svolgere il primo esercizio nazionale di valutazione ex post della ricerca italiana, relativo al triennio 2001-2003, sulla scia dell’inglese Research assessment exercise, giunto dopo 20 anni alla sua quinta edizione. La signora ministro si impegna poi ad allocare un terzo dei finanziamenti ordinari dell’università e degli enti di ricerca secondo l’ordinamento meritocratico di tali strutture fornitole da un board dì 7 membri del Civr; questo si appoggia sui giudizi di 20 panel di area appositamente creati, uno per ciascuno dei 14 settori di ricerca definiti dal Cun più 6 aree speciali, i quali, a loro volta, si basano sulla valutazione indipendente di almeno due esperti, di cui un quarto stranieri, su ognuno dei migliori prodotti di ricerca autoselezionati, area per area, dalle strutture. L’esame da parte dei panel della performance scientifica nelle varie aree di ricerca delle 102 principali strutture del nostro Paese (incluse tutte le 77 università, tra statali e legalmente riconosciute) termina nel dicembre del 2005, avendo coinvolto 150 panelisti, 6 mila esperti, circa 18 mila prodotti, con un costo complessivo di 3 milioni e mezzo di euro: per la prima volta nella storia del nostro Paese, nel gennaio 2006 un rapporto scritto identifica, per ognuno dei 20 settori disciplinari, un ordinamento quantitativo completo delle strutture, in ragione della valutazione ex post dei prodotti di ricerca di quell’area. Nonostante nel rapporto conclusivo dei panel emergano dalla valutazione, area per area, le migliori come le peggiori strutture, e ciascuna sia con piena trasparenza e inflessibilmente giudicata in un ranking numerico, nessuna di esse lamenta ingiustizie. Anzi, da più parti si esprime la speranza che innovazioni ancor più profonde conseguano dal rapporto finale del board del Civr, destinato a dare un giudizio circostanziato delle strutture, dunque una valutazione non più soltanto area per area (purtroppo tale rapporto finale è ancora in attesa di essere presentato al ministro Mussi, per poter poi divenire di dominio pubblico): ad esempio Gianni Toniolo scrive il 21 marzo 2006 sul Sole 24 0re che, grazie al Civr, «enti, dipartimenti, facoltà si stanno interrogando sui motivi dei propri successi e dei propri fallimenti... sui costi di una politica di assunzioni e promozioni attenta a parametri (scuole, vicinanza ideologica, appartenenza alla sede, anzianità di servizio) diversi da quelli dell’eccellenza scientifica. Si tratta di novità non da poco. Ma i cambiamenti di mentalità, di cultura, durano poco se non sono sostenuti da incentivi adeguati e necessari, il 1° essendo l’assegnazione dei finanziamenti alla ricerca sulla base delle valutazioni di un Civr trasformato in Autorità indipendente per la valutazione della ricerca». Nell’iniziale giorno di primavera di quest’anno, quando Toniolo così si esprime, molti ritengono che, se il centrosinistra tornasse, di lì a qualche giorno, al governo, il principio della valutazione nella ricerca uscirebbe rafforzato, perché la proposta di legge dei Ds del gennaio 2006 (con primi firmatari l’allora senatore, oggi sottosegretario al Miur, Luciano Modica e l’onorevole Walter Tocci) prevede l’istituzione di quel la specifica Autorità, cui riserva la funzione sia di effettuare «sulla base dei risultati delle sue attività di valutazione, la ripartizione tra le università e tra gli enti di ricerca di una quota» dei loro finanziamenti ordinari, sia di determinare «procedure, metodologie e tempi operativi», necessari alla valutazione periodica dell’attività dei singoli ricercatori.
Viceversa, il decreto legge n. 262 del nuovo esecutivo, definitivamente convertito in legge il 23 novembre 2006, da un lato istituisce non un’Autorità indipendente bensì una mera Agenzia ministeriale (chiamata Anvur), solo dotata di «personalità giuridica dì diritto pubblico» e, dall’altro lato, ne sancisce la diminutio, perché la priva dei principali compiti sopra menzionati nella proposta di legge Modica-Tocci. Rimane soltanto che «i risultati delle attività di valutazione dell’Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l’allocazione dei finanziamenti statali all’università e agli enti di ricerca». In aggiunta, i fondi annui assegnati all’Agenzia sono di poco superiori a quelli per il 2006 di uno dei due Comitati (il Cnvsu), che, con il Civr, confluisce nell’Agenzia, mentre al Civr medesimo, cui nel frattempo si chiede di procedere al secondo esercizio di valutazione triennale della ricerca per il periodo 2004-2006, la Finanziaria non sembra dare alcun quattrino nel 2007. Infine, l’indebolimento dell’Agenzia è confermato dalla lettera che l’11 novembre 2006 il consigliere del ministro Mussi, Giovanni Ragone, invia a una sigla sindacale, da sempre ostile alla centralità della valutazione della ricerca nella proposta Modica-Tocci, affermando che «quote crescenti del finanziamento pubblico andranno distribuite fra le strutture in relazione ai risultati... su decisione del governo, non dell’Agenzia... L’Agenzia, almeno in un primo tempo, dovrà provare a valutare i risultati delle strutture e dei progetti», non (aggiungo io) dei singoli ricercatori.
Viceversa, il decreto legge n. 262 del nuovo esecutivo, definitivamente convertito in legge il 23 novembre 2006, da un lato istituisce non un’Autorità indipendente bensì una mera Agenzia ministeriale (chiamata Anvur), solo dotata di «personalità giuridica dì diritto pubblico» e, dall’altro lato, ne sancisce la diminutio, perché la priva dei principali compiti sopra menzionati nella proposta di legge Modica-Tocci. Rimane soltanto che «i risultati delle attività di valutazione dell’Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l’allocazione dei finanziamenti statali all’università e agli enti di ricerca». In aggiunta, i fondi annui assegnati all’Agenzia sono di poco superiori a quelli per il 2006 di uno dei due Comitati (il Cnvsu), che, con il Civr, confluisce nell’Agenzia, mentre al Civr medesimo, cui nel frattempo si chiede di procedere al secondo esercizio di valutazione triennale della ricerca per il periodo 2004-2006, la Finanziaria non sembra dare alcun quattrino nel 2007. Infine, l’indebolimento dell’Agenzia è confermato dalla lettera che l’11 novembre 2006 il consigliere del ministro Mussi, Giovanni Ragone, invia a una sigla sindacale, da sempre ostile alla centralità della valutazione della ricerca nella proposta Modica-Tocci, affermando che «quote crescenti del finanziamento pubblico andranno distribuite fra le strutture in relazione ai risultati... su decisione del governo, non dell’Agenzia... L’Agenzia, almeno in un primo tempo, dovrà provare a valutare i risultati delle strutture e dei progetti», non (aggiungo io) dei singoli ricercatori.
Dopo 440 anni pare, dunque, ancora prematuro il tentativo di concretizzare quell’aspirazione allegorica, magistralmente illustrata da Paolo Veronese nella lunetta affrescata della Villa palladiana di Maser, dove «l’Oblio scopre il Merito».
fiorella.kostoris@tin.it
fiorella.kostoris@tin.it
4 - Europa del 29 novembre 2006
Stanchi dell’università di massa
Dalla Chiesa ai rettori: prestiti d’onore e abolizione del valore legale del titolo
Visto da Bologna il mondo dell’università italiano sembra più vecchio. Sarà che è la sede della più antica università del mondo. Sarà che i rettori, anche in borghese, senza tocco e toga, si fanno riconoscere. Sarà che se uno di loro, Angelo Provasoli della Bocconi, prova a raccontare come ha fatto lui, tutti lo ascoltano stupiti, un po’ scettici e molto molto invidiosi. Doveva essere un’occasione per fare il punto, mettere in fila qualche idea da recapitare al ministro. Si è trasformato in una seduta di autoanalisi con i rettori a chiedersi perché, ancora una volta, l’Accademia resta 1a bella addormentata, un potere senza potere, l’illustre dimenticata. Sì, perché la Moratti era la Moratti. E pazienza. Con Berlusconi la diffidenza era di pelle, ampiamente ricambiata Ma dal Professore, uno di loro e per di più di Bologna, ci si aspettava di più. E invece niente. "f università oltre la -Finanziaria" era il titolo del seminario a porte chiuse organizzato Nando Dalla Chiesa, sottosegretario a ministero dell’università, e ospitato Fabio Roversi Monaco, presidente della fondazione CarisUo, già magnifico dell’Alma Mater. Oltre la Finanziaria, appunto. Zero a zero e palla al centro. Anche perché, prima di lamentarsi, le università italiane hanno parecchio da farsi perdonare e i tantissimi rettori presenti lo ammettono, prendendo alla lettera l’invito di Dalla Chiesa a «una discussione libera, per dirsi cose che anche alla conferenza dei rettori non si dicono».
Nessun processo, per carità. Ma lo stato di salute dell’università italiana promette male. E non per le graduatorie internazionali («basta chiamare qualche premio Nobel e si risale») che le vedono sempre galleggiare tra metà classifica e zona retrocessione, ma perché la qualità media si è abbassata, la ricerca è quella che è, i concorsi spesso una farsa, la governance è vecchia di trent’anni, la burocrazia rema contro. Sembra di capire che l’ università di massa, nobile conquista degli anni Sessanta, sia in piena crisi da inflazione. Troppi corsi di laurea, troppi docenti, troppe sedi, troppi voti alti, troppi studenti iscritti e ancora pochi laureati. I:autonomia universitaria (un valore, concordano tutti) è scoppiata in mano agli atenei che hanno aperto sedi e corsi di laurea un po’ ovunque. Gustoso il racconto del rettore di Genova, Gaetano Bignardi, che ha dovuto resistere alle pressioni politico-clientelari per non aprire una sede di agraria ad Albenga, in una regione dove non c’è un solo podere e gli studenti interessati a sementi e coltivazioni sono due. Ben venga, allora, la moratoria del ministro Mussi che ha detto stop alla moltiplicazione anarchica di sedi, corsi e lauree. Oggi siamo a 77 atenei, 450 sedi, 5434 corsi di studio.
Resta il fatto che così non va. Che fare? Certo, servono più fondi (c’è chi invoca un cuneo fiscale per l’Università nella Finanziaria delfanno prossimo), ma c’è bisogno di una scossa. È Andrea Cammelli, fondatore di Alma Iaurea, a snocciolare un po’ di cifre. Da un paio di anni si assiste a un calo delle iscrizioni, solo in parte spiegabile con il calo demografico. L’università di massa ha di fatto aumentato la mobilità Uilità sociale (tre laureati su quattro vengono da famiglie di non laureati) e aumentato l’occupazione (a cinque anni dal titolo quasi tutti hanno un lavoro) ma i laureati spesso finiscono nei call-center. La laurea è tornata a essere solo un foglio di carta. Perché con il3+2 ci si laurea più in fretta e con voti tanto alti che le imprese non li considerano più un biglietto da visita per i mondo del lavoro. Il biennio di specialistica di specialistico ha ben poco. Serve più selezione all’entrata e più meritocrazia nei percorsi di studio «perché l’Uuniversità torni ad essere per i capaci e i meritevoli».
Resta il fatto che così non va. Che fare? Certo, servono più fondi (c’è chi invoca un cuneo fiscale per l’Università nella Finanziaria delfanno prossimo), ma c’è bisogno di una scossa. È Andrea Cammelli, fondatore di Alma Iaurea, a snocciolare un po’ di cifre. Da un paio di anni si assiste a un calo delle iscrizioni, solo in parte spiegabile con il calo demografico. L’università di massa ha di fatto aumentato la mobilità Uilità sociale (tre laureati su quattro vengono da famiglie di non laureati) e aumentato l’occupazione (a cinque anni dal titolo quasi tutti hanno un lavoro) ma i laureati spesso finiscono nei call-center. La laurea è tornata a essere solo un foglio di carta. Perché con il3+2 ci si laurea più in fretta e con voti tanto alti che le imprese non li considerano più un biglietto da visita per i mondo del lavoro. Il biennio di specialistica di specialistico ha ben poco. Serve più selezione all’entrata e più meritocrazia nei percorsi di studio «perché l’Uuniversità torni ad essere per i capaci e i meritevoli».
CHI FA DIDATTICA E CHI FA RICERCA
La sensazione è che l’Accademia, pur gelosa della propria autonomia, sia incapace di riformarsi da sola, e attenda dal governo una mano, un indirizzo, un sistema di regole nuove, l’indicazione delle priorità. Lo si capisce quando l’illustrazione del modello Bocconi (governance e reclutamento "all’americana") è seguita da un coro di "come vorrei essere al tuo posto, "che invidia", "come sarebbe bello". Una nuova governance è la parola-mantra che ripetono un po’ tutti ma che nessuno ateneo è in grado di darsi da solo. «Dubito che gli
atenei possano trovare al proprio interno le forze per organizzarsi in modo nuovo - ammette il rettore di Bologna Calzolari-. Oggi ci sono 150 organi, ogni decisione richiede processi spaventosi». «Autonomia senza competizione non ha senso», spiega Provasoli della Bocconi dove autonomia significa docenti a chiamata, stipendi variabili, fund raising.
Anche in Italia, e con trent’anni di ritardo, si potrebbe andare verso un sistema di separazione tra teaching university (con vocazione alla didattica) e resarch university (che puntano sulla ricerca) sul modello anglosassone. Non tutti devono fare tutto: ogni ateneo dovrà concentrarsi su quello che sa fare meglio in un sistema a geometria variabile. Ma non basta.
Se si vuole un sistema di qualità (soprattutto per specialistica e dottorato) servono più soldi e nessuno più s’illude che lo stato possa pagare tutto a tutti. «l’università non può costare come rasilo nido, il futuro è sempre un investimento», dice Dalla Chiesa che rilancia coraggiosamente due proposte «politicamente cruciali», sulle quali il consenso politico a sinistra non è così scontato: prestiti d’onore e borse di studio più ricche e selettive («non c’è criterio di merito per l’accesso al primo anno e il reddito è spesso infedele») e la possibile abolizione del valore legale del titolo di studio, un ballon d’essai che gela una platea che lo considera ancora un tabù, per innescare un processo virtuoso di competizione tra gli atenei e perché «ogni università abbia i migliori docenti che può permettersi».
Se si vuole un sistema di qualità (soprattutto per specialistica e dottorato) servono più soldi e nessuno più s’illude che lo stato possa pagare tutto a tutti. «l’università non può costare come rasilo nido, il futuro è sempre un investimento», dice Dalla Chiesa che rilancia coraggiosamente due proposte «politicamente cruciali», sulle quali il consenso politico a sinistra non è così scontato: prestiti d’onore e borse di studio più ricche e selettive («non c’è criterio di merito per l’accesso al primo anno e il reddito è spesso infedele») e la possibile abolizione del valore legale del titolo di studio, un ballon d’essai che gela una platea che lo considera ancora un tabù, per innescare un processo virtuoso di competizione tra gli atenei e perché «ogni università abbia i migliori docenti che può permettersi».
II TABÙ DELLE TASSE
«La nostra didattica sta peggio della nostra ricerca», ammette il ministro Arturo Parisi di passaggio al seminario, e Patrizio Bianchi, rettore a Ferrara, lancia una provocazione: «Un dentista ci costa 30 mila euro l’anno e ne paga solo due. Perché io devo pagare la preparazione di un dentista, quale contributo dà al nostro sistema? Serve un progetto-paese. L’errore tragico della Finanziaria e del decreto Bersani è stato di riportarci a discutere di tagli di spesa come se il problema dell’università italiana fosse quello. Ci stiamo mangiando consensi».
Oggi più del 90 per cento del Fondo di finanziamento ordinario se ne va per pagare gli stipendi al personale di ruolo. Probabilmente si andrà verso un progressivo innalzamento delle tasse universitarie. Fondi per la ricerca possono arrivare dalle fondazioni bancarie e dalle imprese perché il mercato dei ricercatori è sempre più mondiale e un giovane cervello va dove ci sono i fondi. «Mentre noi mandiamo i nostri giovani Erasmus in Romania perché costa meno», confessa il rettore di Camerino. Anche il reclutamento dei docenti e i percorsi di carriera devono cambiare, come sottolinea Ferdinando Latteri, ex rettore di Catania e responsabile università della Margherita: la legge del 1980 è superata nei fatti, e nel 2015 una valanga di docenti ordinari se ne andrà in pensione. Un’occasione irripetibile per voltare pagina.
Oggi più del 90 per cento del Fondo di finanziamento ordinario se ne va per pagare gli stipendi al personale di ruolo. Probabilmente si andrà verso un progressivo innalzamento delle tasse universitarie. Fondi per la ricerca possono arrivare dalle fondazioni bancarie e dalle imprese perché il mercato dei ricercatori è sempre più mondiale e un giovane cervello va dove ci sono i fondi. «Mentre noi mandiamo i nostri giovani Erasmus in Romania perché costa meno», confessa il rettore di Camerino. Anche il reclutamento dei docenti e i percorsi di carriera devono cambiare, come sottolinea Ferdinando Latteri, ex rettore di Catania e responsabile università della Margherita: la legge del 1980 è superata nei fatti, e nel 2015 una valanga di docenti ordinari se ne andrà in pensione. Un’occasione irripetibile per voltare pagina.
Il modello degli anni Sessanta è in crisi: troppi docenti, troppi corsi e pochi laureati, mentre servono più soldi, qualità e una selezione mirata
5 - Il Sole 24 Ore del 29 novembre 2006
Sanatorie
L’Italia, un capitale di talenti sprecati
L’assunzione senza concorso di 300mila precari risponde a criteri sociali, ma allontana una volta di più la professionalità nella pubblica amministrazione
Paesi capaci di far nascere atenei di qualità e attenti alla ricerca, il Governo, dopo aver messo l’università tra le istituzioni o la competitività - Si a Politiche per atrarre i cervelli, prioritarie, oggi ridimensiona l’impegno e sorvola sulla selezione innovazione richiede investimenti e risorse umane preparate: decisive le scelte meritocratiche
ECONOMIA DELLA CONOSCENZA Il RUOLO DEGLI "INTANGIBILI"
Perché oggi si parla così tanto di economia della conoscenza? Agli inizi del secolo scorso la crescita del capitale tangibile (strutture fisiche, macchinari, risorse naturali, eccetera) per ora lavorata contribuiva per i due terzi all’aumento della produttività del lavoro. Tale contributo è sceso alla fine del ventesimo secolo a un quinto. Cosa ha preso il suo posto? È stata la crescita della quota di un altro tipo di capitale, chiamato intangibile, costituito dalla conoscenza e dal capitale umano (in particolare istruzione, formazione, ricerca tit sviluppo, miglioramento delle strutture organizzative). Oggi lo stock di questo capitale è largamente dominante su quello tangibile (in Usa nel 1990 32.819 miliardi rispetto a 28.525 miliardi di dollari). Cosa significano questi dati? Che i Paesi più in grado di generare buone università, ricerca, formazione, organizzazioni e servizi validi sono anche quelli più competitivi a livello economico.
Il concetto di economia della conoscenza era stato introdotto negli anni 60 dallo studioso austriaco Fritz Machlup ed è stato ripreso più volte da vari studiosi, fra cui Kenneth Arrow, fino al suo ingresso anche nelle analisi dell’Ocse ad opera di Dominique Foray. Perché si parla dell’economia della conoscenza separata da quella dei capitali tangibili? Per una serie di caratteristiche peculiari di questo bene: è difficilmente eseludibile, cioè chi lo produce non riesce ad evitare che i suoi benefici vengano appropriati anche dagli altri; non è rivale, cioè il suo consumo non porta al suo esaurimento; è cumulativo, cioè da questo bene se ne producono altri. Per capire le tre proprietà si pensi agli esempi della legge della termodinamica, del teorema di Talete o di una mappa geografica. Chiunque ha potuto utilizzarli dopo la loro scoperta, innumerevoli volte, per risolvere problemi e generare nuova conoscenza. Opposte caratteristiche sono tipiche di un bene materiale come qualsiasi prodotto di consumo. L’economia della conoscenza di cui tutti parlano, ma pochi almeno in Italia vogliono realizzare, pone però delle condizioni. Una delle più importanti e, per il nostro Paese, più difficile è che il capitale umano deve essere selezionato su base meritocratica. Poiché la conoscenza ha bisogno, per essere generata, di menti ben preparate e formate devono essere promossi e incentivati i più capaci in questo particolare tipo di produzione. Quindi i Paesi che sono in grado di formare e attirare i migliori talenti sono quelli che hanno le economie della conoscenza più competitive. Vi sono, a riguardo, vari indicatori che correlano positivamente talento e professionalità creative con il tasso di sviluppo economico e tecnologico. Siamo alla guerra dichiarata dei talenti e del merito. Anche in Italia tutti, a destra e a sinistra, sembrano mettere come obiettivo prioritario delle politiche pubbliche l’economia della conoscenza.
Ciò avviene sempre nei programmi elettorali e viene dimenticato, puntualmente, nella prima Finanziaria. Prendiamo l’università. Ora sappiamo che vi è una evidente correlazione fra qualità dell’insegnamento accademico e performance economica di un Paese come di un singolo laureato. I Paesi che hanno migliori università, secondo gli indicatori convergenti delle varie graduatorie internazionali, sono anche quelli che hanno più capacità innovativa e di crescita. Il nostro governo, dopo avere messo nel suo programma l’università, fra le principali priorità della sua azione, si sta comportando come i governi precedenti nel momento delle scelte. Non sta incidendo significativamente, in senso meritocratico, sulle regole dell’organizzazione didattica e scientifica dell’università e ha, nello stesso tempo, indebolito finanziariamente l’intero sistema. Questa scarsa attenzione ai criteri di merito per selezionare e promuovere il capitale umano la si riscontra, poi, in un’altra misura presentata in questi giorni nella Finanziaria. Si prevede l’assunzione senza concorso di 300mila unità di personale precario appartenenti agli enti locali, nazionali e alla scuola. Questa gigantesca sanatoria, senz’altro motivata dalle migliori finalità di tipo sociale, non farà che ridurre, ulteriormente, il livello di professionalità presente nella pubblica amministrazione e creare aspettative perverse ai giovani impegnati a orientarsi nelle scelte per il proprio futuro di lavoro.
Quanti anni luce separano il nostro Paese dalla profezia di Winston Churchill nel suo discorso del 1943 all’Università di Harvard: «Gli imperi del futuro saranno imperi della mente».
Riccardo Viale
Riccardo Viale
6 - Il Sole 24 Ore del 30 novembre 2006
Università povera di qualità
Le resistenze al cambiamento - il confronto con la Gran Bretagna evidenzia l’inadeguatezza italiana
Si ripete spesso che in Italia si spende troppo poco per l’università e che ciò sia la causa principale della bassa qualità della didattica (tanti studenti, pochi docenti) e della ricerca (pochi fondi a disposizione e troppi impegni didattici). Quanto c’è di vero in questo? Un modo per appurarlo è confrontare 63 atenei statali italiani con il sistema universitario britannico. Quest’ultimo è un valido termine di paragone perché è anch’esso interamente pubblico, ma con un’organizzazione per certi versi profondamente diversa da quella italiana e con una produttività scientifica superiore.
LA DIDATTICA E GLI STUDENTI
La didattica ha ovviamente una componente qualitativa che è quasi impossibile misurare. Ma due utili, seppure imperfetti, indicatori quantitativi sono il rapporto studenti/docenti, che mostra quanto siano seguiti in media gli studenti e la spesa per studente, che esprime la disponibilità di risorse. La tabella in alto a destra contiene alcune possibili versioni del rapporto studenti/docenti (i dati si riferiscono al 2004-2005 per il Regno Unito, al 2003-04 per l’Italia). Nella prima riga, il rapporto tra studenti undergraduate (cioè esclusi gli studenti di scuole di specializzazione e di corsi di master e dottorato) e docenti di ruolo in Italia è circa il 50% più alto che nel Regno Unito (dove ho considerato di ruolo i docenti con contratto permanente): 30 studenti per ogni docente in Italia contro 20 nel Regno Unito. Ma questo dato, spesso citato, non tiene conto del fatto che molti studenti in Italia sono iscritti ma non frequentano.
Il numero di studenti "equivalenti a tempo pieno" (Etp) viene calcolato attribuendo a uno studente chepassasoloili5% dei crediti previsti nell’anno cui è iscritto un peso del 15%, e così via La seconda riga mostra che il rapporto fra studenti undergraduate Etp e i docenti di ruolo è identico nel Regno Unito e in Italia. Non è dunque vero che nel Regno Unito gli studenti siano più seguiti; e non è vero che i docenti in Italia siano oberati di impegni didattici rispetto ai colleghi britannici. In entrambi i Paesi vi sono poi docenti non di ruolo; inoltre soprattutto nel Regno Unito molti professori si dedicano esclusivamente alla ricerca. Il rapporto tra studenti un dergraduate Etp e professori totali (di ruolo e non di ruolo) che non si dedicano esclusivamente alla ricerca è più basso in Italia (terza riga). Se si includono tra gli studenti anche quelli di scuole di specializzazione, master e dottorato, il rapporto rimane più basso in Italia (quarta riga).
Infine, non tutti i docenti insegnano a tempo pieno; il rapporto tra studenti totali Etp e docenti totali Etp (quinta riga) rimane più basso in Italia (si tenga però presente che il calcolo dei docenti Etp in Italia è piuttosto aleatorio).
Nel 2004-05 per ciascun studente undergraduate nel Regno Unito si spendevano 19.600 dollari, a parità di potere d’acquisto; in Italia, il 20% in meno: 15.400 dollari. Anche in termini di studenti totali Etp la spesa italiana è circa il 20% inferiore a quella britannica Un divario, quindi; non drammatico.
I DOCENTI
Passiamo ora ai docenti. E’ vero che sono sottopagati in Italia? La prima riga della tabella in basso a destra, con dati desunti dai bilanci delle università, mostra che le remunerazioni medie per docenti di ruolo e non di ruolo sono simili nei due Paesi. Tuttavia, in Italia la retribuzione media per docenti non di ruolo è molto difficile da determinare; e la retribuzione media italiana è certamente sottostimata Limitandoci quindi ai docenti di ruolo, la seconda riga dice che la remunerazione media per i docenti di ruolo in Italia è molto più alta della spesa media per docente nel Regno Unito (dove però si considerano tutti i docenti, perché la retribuzione media per docenti di ruolo non è isolabile).
Un indicatore più diretta è il confronto tra le retribuzioni tabellari dei docenti di ruolo nei due Paesi ai vari livelli accademici. La tabella qui sopra per ogni livello accademico confronta i minimi e i massimi tabellari (colonne l e 2) e le retribuzioni medie effettive (colonna 3) in Italia con le stesse grandezze di un campione di 10 università britanniche (colonne 4,5 e 6) e nell’Università di Oxford (colonne 7 e 8; i dati delle università britanniche sono desunti da un’inchiesta sui compensi nelle università del Commonwealth). Ne emerge un fenomeno evidente: la remunerazione di entrata (ricercatore non confermato e gradino iniziale di lecturer A) è effettivamente più bassa in Italia; tuttavia da noi si progredisce molto velocemente, cosicché la retribuzione massima ma soprattutto quella media dei ricercatori sono molto più alte. Analogamente, lo stipendio d’ingresso di un associato non confermato è lievemente inferiore allo stipendio minimo di un senior lecturer. ma anche in questo caso la progressione è molto – più elevata in Italia, tanto che lo stipendio medio degli associati italiani è superiore a quello massimo dei senior lecturer a Oxford.
Il messaggio è chiaro ed è confermato anche da un confronto con le retribuzioni dei docenti statunitensi in un lavoro che ho scritto con Stefano Gagliarducci, Andrea Ichino e Giovanni Peri: in Italia i docenti di ruolo sono> W media, meglio pagati che nel Regno Unito; tuttavia, sono meno remunerati i docenti giovani e con poca anzianità, cioè proprio quelli che sono tipicamente più produttivi e più motivati a fare ricerca, per stipendiare moltissimo i docenti più anziani, indipendentemente dalla loro produttività scientifica. Esattamente l’opposto di quanto si dovrebbe fare per incentivare la ricerca seria. Invece di prendersela con il ministro dell’Economia, i ricercatori giovani e produttivi sottopagati e gli studenti dovrebbero protestare Contro i rettori che chiedono sempre soldi ma difendono a oltranza uno status quo
Un indicatore più diretta è il confronto tra le retribuzioni tabellari dei docenti di ruolo nei due Paesi ai vari livelli accademici. La tabella qui sopra per ogni livello accademico confronta i minimi e i massimi tabellari (colonne l e 2) e le retribuzioni medie effettive (colonna 3) in Italia con le stesse grandezze di un campione di 10 università britanniche (colonne 4,5 e 6) e nell’Università di Oxford (colonne 7 e 8; i dati delle università britanniche sono desunti da un’inchiesta sui compensi nelle università del Commonwealth). Ne emerge un fenomeno evidente: la remunerazione di entrata (ricercatore non confermato e gradino iniziale di lecturer A) è effettivamente più bassa in Italia; tuttavia da noi si progredisce molto velocemente, cosicché la retribuzione massima ma soprattutto quella media dei ricercatori sono molto più alte. Analogamente, lo stipendio d’ingresso di un associato non confermato è lievemente inferiore allo stipendio minimo di un senior lecturer. ma anche in questo caso la progressione è molto – più elevata in Italia, tanto che lo stipendio medio degli associati italiani è superiore a quello massimo dei senior lecturer a Oxford.
Il messaggio è chiaro ed è confermato anche da un confronto con le retribuzioni dei docenti statunitensi in un lavoro che ho scritto con Stefano Gagliarducci, Andrea Ichino e Giovanni Peri: in Italia i docenti di ruolo sono> W media, meglio pagati che nel Regno Unito; tuttavia, sono meno remunerati i docenti giovani e con poca anzianità, cioè proprio quelli che sono tipicamente più produttivi e più motivati a fare ricerca, per stipendiare moltissimo i docenti più anziani, indipendentemente dalla loro produttività scientifica. Esattamente l’opposto di quanto si dovrebbe fare per incentivare la ricerca seria. Invece di prendersela con il ministro dell’Economia, i ricercatori giovani e produttivi sottopagati e gli studenti dovrebbero protestare Contro i rettori che chiedono sempre soldi ma difendono a oltranza uno status quo
indifendibile: un sistema basato esclusivamente sull’anzianità dì servizio che premia i docenti fannulloni e incompetenti.
Roberto Perotti
roberto.perotti@unibocconi.it
7 - Il Sole 24 Ore del 30 Novembre 2006
Concorrenza e merito
L’università degli ipocriti: la soluzione è privatizzare
Nonostante i continui lamenti dei rettori, il problema dell’università italiana non è la mancanza di risorse, ma come vengono distribuite. Come mostrano le tabelle, rispetto al sistema inglese (preso a confronto perché completamente pubblico, come gran parte di quello italiano) gli studenti italiani non sono meno seguiti né i professori sono meno pagati. L’università italiana è però meno produttiva; la soluzione che tutti invocano è il binomio di concorrenza e merito. A parole, chi potrebbe opporsi? Ma in pratica, concorrenza e merito significano penalizzare chi non produce e premiare chi fa bene: in altri termini, i "soldi devono seguire la qualità", a livello sia di ateneo sia di individui. E qui cominciano le difficoltà.
Concettualmente, ci sono due metodi per far ottenere questo risultato. Il primo è applicabile in un sistema pubblico, e in una certa misura è stato adottato nel Regno Unito. Prevede che una quota dei finanziamenti alle università venga distribuita in base alla valutazione della ricerca e della didattica. Ciò funziona solo se i fondi così allocati sono sostanziali (il 30% del totale nel Regno Unito) e distribuiti impietosamente a pochi atenei eccellenti, promuovendo così una distinzione netta fra quelli di serie A e quelli di serie B. Inoltre, è necessario liberalizzare assunzioni e stipendi; niente più concorsi né tabelle retributive, quindi: ognuno fa ciò che vuole. Intestardirsi nell’impossibile missione di riformare i concorsi è una strada senza uscita: i concorsi hanno fallito miseramente e qualsiasi cambiamento è stato e sarà facilmente aggirabile da chiunque voglia usarli a fini clientelari. Gli atenei devono poter competere per accaparrarsi i ricercatori migliori, pagando, se lo ritengono opportuno, uno scienziato superstar di 3o anni il doppio di un ordinario di 6o anni che non ha mai pubblicato niente: in che altro modo si esprime la concorrenza? I ricercatori migliori portano prestigio, studenti e finanziamenti; ciò a sua volta stimolerà gli altri docenti a fare buona ricerca e buona didattica.
Riguardo a quest’ultima, niente più 3+2 e altre formule centralizzate e cervellotiche, ognuno sceglie liberamente e chi ha successo attira studenti e finanziamenti e verrà imitato, chi fallisce cambia o scompare.
L’università italiana ha dunque bisogno di abolire i concorsi, liberalizzare stipendi, assunzioni e didattica, far pagare agli studenti più abbienti il costo dei servizi che ricevono, finanziare chi opera bene, lasciare scomparire chi opera male. E tutte queste riforme vanno attuate insieme: misure ben intenzionate ma isolate non cambieranno niente, anzi, possono facilmente peggiorare la situazione. Se si liberalizzano assunzioni e stipendi ma non si cambia il modo di finanziamento, chi oggi assume i figli degli amici ne approfitterà per coprirli anche di soldi. Per evitarlo, i finanziamenti devono premiare la qualità, cosicché chi assume in modo clientelare ne paghi le conseguenze. Oppure, se aumentano le rette studentesche ma non cambia il sistema di assunzioni e retribuzione, il barone locale continuerà ad arruolare incompetenti e a offrire corsi scadenti: gli studenti se ne andranno ma il suo stipendio continuerà a salire per anzianità esattamente come prima. Oppure ancora, se si introduce un sistema di valutazione ma non si attribuisce alle università libertà di assunzione e remunerazione che strumenti gli si dà per competere e a cosa serve la valutazione?
Realisticamente, tutte queste riforme non saranno mai attuate in Italia, se non marginalmente e inutilmente; anzi, con effetti controproducenti. È utopistico pensare di valutare e confrontare centralmente la didattica di un docente di veterinaria a Trento e di un docente di filosofia a Catania E decine di università italiane non producono alcuna ricerca di rilievo e offrono una didattica spaventosa: all’Agenzia della valutazione creata dalla Finanziaria verrà mai consentito di negare loro (seppure gradualmente) il 30% dei finanziamenti attuali, condannandole alla fine che meritano? 0 quando mai si permetterà a un giovane di guadagnare il doppio di un anziano e a un ateneo di organizzarsi come vuole e assumere chi vuole?Le riforme politicamente fattibili sono, al più, un brodino caldo. Invece di continuare ad auto-ingannarci, forse faremmo bene a pensare al secondo metodo per introdurre la concorrenza e il merito: privatizzare. Certamente anche questa è una strada di difficilissima praticabilità politica, ma almeno ha efficacia non illusoria. In un sistema privato, se dei baroni promuovono incompetenti o insegnano male, l’ateneo perde studenti e rette, prestigio, commesse e finanziamenti. Alla fine ne risentono i baroni stessi: la loro retribuzione scende, il loro prestigio accademico diminuisce e se l’ateneo è costretto a chiudere perdono il posto di lavoro. Questa è la migliore assicurazione contro clientelismi e inefficienze e il modo più certo per garantire che le esigenze dei consumatori (gli studenti e le loro famiglie) siano tenute in considerazione.
Sento già le grida di indignazione: l’università solo per i ricchi? Non tutti però sanno che al Sud solo il 4%,. degli studenti universitari provengono dal 20% più povero delle famiglie: il sistema attuale è un Robin Hood al contrario che usa le imposte dei meno abbienti per finanziare gli studi gratuiti dei ricchi. Non è difficile fare meglio: un’università privata con un sistema statale di borse di studio e prestiti condizionati al reddito, e con restituzione graduata a seconda del guadagno post-laurea, come in Australia 1 ricchi pagheranno finalmente il costo dell’investimento in educazione, mentre i meno abbienti potranno "ente ottenere un servizio decente.
La privatizzazione non solleva, dunque, problemi di equità. Pone, però, un problema più sottile: se l0 Stato sussidia le rette dei meno abbienti, questo induce gli atenei ad aumentarle per appropriarsi dei sussidi agli studenti, come avvenne in Cile negli anni 90. Affrontare questo problema richiede un’analisi seria e non facile, ma senz’altro più produttiva che ostinarsi a proporre aggiustamenti marginali e inutili su un sistema fallimentare. L’università, tutti lo riconoscono, ha bisogno di è concorrenza e merito; in altre parole, di mercato. Nel clima culturale attuale questa parola è però un anatema: ci si illude di poterne replicare i lati positivi con l’ennesimo tentativo di pianificazione illuminata, evitando però gli antiestetici effetti di mercificazione della cultura che ci vogliono propinare quei sempliciotti degli yankees. Questa illusione continua a costarci cara: è ora di riconoscere la necessità di un cambiamento radicale e discutere gli aspetti concreti del nuovo sistema.
Roberto Perotti
Roberto Perotti
roberto.perotti@unibocconi.it
8 - Il Manifesto del 30 novembre 2006
Ricercatori precari, il governo dà i numeri
Licenziare i precari per ridurre il precariato non sembra essere una proposta di sinistra, sfortunatamente è contenuta in una disposizione della finanziaria, confermata nel maxiemendamento. Infatti una disposizione impone che negli enti pubblici, e in particolare negli enti di ricerca, la spesa per contratti a tempo determinato e co.co.co. non superi per il 2007 il 40% di quella in essere nel 2003. Gli effetti di ogni norma devono essere giudicati dal contesto in cui si applica. Anche se sono convinto che sia insensata in generale, mi limiterò a discuterla per gli enti di ricerca, dove la situazione mi è molto chiara per diretta esperienza personale. Qui l’effetto principale sarà di ridurre a zero il numero di contratti rinnovati e di nuovi contratti a tempo determinato, in quanto la sola spesa per il personale precario non in scadenza supera di gran, lunga il 40% del 2003 e non ci sono più margini di manovra.
Infatti una norma del genere potrebbe anche essere utile per combattere il precariato se gli enti di ricerca fossero liberi di procedere a assunzioni a tempo indeterminato; tuttavia questo non è: un altro articolo della finanziaria pone dei limiti molto stretti sulle nuove assunzioni che, a parte interventi straordinari, sono proporzionali ai pensionamenti e possibili solo a partire dal 2008.
Limitare contemporaneamente sia i contratti a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato e co.co.co., implica necessariamente dover licenziare gli sfortunati precari il cui contratto scade nel 2007 (in alcuni enti di ricerca - per esempio nel Cnr - molti precari il cui contratto scadeva nel 2006 sono stati più fortunati in quanto hanno avuto il loro contratto prorogato, il 30 dicembre del 2005, per altri cinque anni, senza nessuna valutazione di merito, per evitare gli effetti di un’analoga norma contenuta nella finanziaria 2006,, che riduceva la percentuale al 60% del 2003).
Non rinnovare i contratti in scadenza è particolarmente grave negli enti di ricerca, dove esistono molti contratti fatti per due anni rinnovabili per altri due e il rinnovo è sempre stato, a meno di inconvenienti gravi, un fatto del tutto formale. Non parliamo poi dei ricercatori più giovani, cui questa norma sbatte la porta in faccia per diversi anni in quanto le poche assunzioni a tempo indeterminato sarebbero monopolizzate dai colleghi più anziani.
Si tratta dunque di una norma folle, che non comporta nessun risparmio in quanto non incide sul bilancio totale a disposizione degli enti ma ne vincola in maniera irragionevole l’utilizzo; questa disposizione deve essere semplicemente eliminata: è una delle tante eredità funeste del governo Berlusconi che l’attuale governo esita a cancellare e che a volte peggiora. In un qualunque paese ragionevole, prima di proporre una norma del genere sarebbe stato eseguito uno studio dettagliato degli effetti, dei vantaggi e degli svantaggi di un tale provvedimento per decidere se la percentuale più opportuna sia il 40% o per esempio il 75%. Questo studio non è stato fatto, la percentuale è stata scelta in maniera del tutto arbitraria dall’ignoto estensore della norma, ignorando i problemi reali.
È triste dover osservare che molti provvedimenti di questo governo si basano su percentuali scelte in maniera cervellotica, indipendenti dal dominio concreto di applicazione; come per esempio il taglio del 20% dei consumi intermedi, il taglio del 12,7 % delle spese ministeriali, disposizioni da applicare in maniera uniforme a tutti i settori della spesa pubblica senza distinzioni di comparto e senza entrare nel merito. Il governo si limita a dare i numeri. Un vecchio slogan del ’68 diceva d’immaginazione al potere».
Non rinnovare i contratti in scadenza è particolarmente grave negli enti di ricerca, dove esistono molti contratti fatti per due anni rinnovabili per altri due e il rinnovo è sempre stato, a meno di inconvenienti gravi, un fatto del tutto formale. Non parliamo poi dei ricercatori più giovani, cui questa norma sbatte la porta in faccia per diversi anni in quanto le poche assunzioni a tempo indeterminato sarebbero monopolizzate dai colleghi più anziani.
Si tratta dunque di una norma folle, che non comporta nessun risparmio in quanto non incide sul bilancio totale a disposizione degli enti ma ne vincola in maniera irragionevole l’utilizzo; questa disposizione deve essere semplicemente eliminata: è una delle tante eredità funeste del governo Berlusconi che l’attuale governo esita a cancellare e che a volte peggiora. In un qualunque paese ragionevole, prima di proporre una norma del genere sarebbe stato eseguito uno studio dettagliato degli effetti, dei vantaggi e degli svantaggi di un tale provvedimento per decidere se la percentuale più opportuna sia il 40% o per esempio il 75%. Questo studio non è stato fatto, la percentuale è stata scelta in maniera del tutto arbitraria dall’ignoto estensore della norma, ignorando i problemi reali.
È triste dover osservare che molti provvedimenti di questo governo si basano su percentuali scelte in maniera cervellotica, indipendenti dal dominio concreto di applicazione; come per esempio il taglio del 20% dei consumi intermedi, il taglio del 12,7 % delle spese ministeriali, disposizioni da applicare in maniera uniforme a tutti i settori della spesa pubblica senza distinzioni di comparto e senza entrare nel merito. Il governo si limita a dare i numeri. Un vecchio slogan del ’68 diceva d’immaginazione al potere».
Sembra che ora questo sogno si stia realizzando, ma sotto forma di incubo.
9 - La Repubblica del 3 dicembre 2006
Europa, il rebus ricerca
Seduto assieme ai miei colleghi accademici nella dorata scomodità dello Sheldonian theatre di Oxford questa settimana, a discutere della futura gestione della più antica università di Inghilterra mi è venuta in mente la considerazione di GK Chesterton che la tradizione è la democrazia dei morti. Un professore di scienze politiche ha osservato che Oxford è una"cooperativa di lavoratori" da 800 anni e questa imponente cifra tonda ha continuato a ricorrere nel corso del dibattito della Congregation, il parlamento sovrano dell’università. Chi si oppone all’ingresso di membri esterni nelle strutture gestionali dell’università lo fa in nome dell’autogoverno democratico e della libertà accademica. I sostenitori della proposta di riforma citano norme moderne per 1a responsabilità esterna e la trasparenza delle istituzioni destinatarie sia di fondi pubblici che di donazioni caritatevoli. Questa volta hanno vinto gli oppositori della riforma, ma si andrà forse al voto per posta di tutti i più di 3.700 membri del parlamento universitario.
Le particolari questioni organizzative in ballo sono complesse, ma l’interrogativo più ampio che pende sul dibattito di Oxford è semplice. Si tratta di stabilire se l’Europa disporrà tra vent’anni di università di ricerca di livello mondiale. Attualmente Oxford e Cambridge sono le uniche università europee a figurare in tutte 1e classifiche delle prime dieci università del mondo, altrimenti dominate dalle università americane. Ma anche Oxford e Cambridge reggono solo per miracolo. Se le cose andranno avanti così senza dubbio retrocederanno. Il soft power della storia, della bellezza, del mito e di una ricca tradizione intellettuale riesce a controbilanciare solo in parte l’ hard power delle spese superiori, dell’organizzazione e dell’innovazione.
La mia vita accademica è divisa tra Oxford e Stanford, e noto la differenza ogni volta che attraverso l’Atlantico. Durante la mia permanenza a Stanford quest’anno l’università stava dando gli ultimi ritocchi ad una nuova campagna di raccolta fondi con l’obiettivo di incassare entro la fine del 2011 la somma di 4,3 miliardi di dollari, avendo già ottenuto impegni di finanziamento per circa 2,2 miliardi. Già ora Stanford beneficia di un finanziamento doppio rispetto ad Oxford. Le rette in media sono cinque volte superiori a quelle richieste da Oxford che, dato il tetto imposto dal governa alle tasse universitarie, calcola di perdere circa 5.000 sterline per ogni studente iscritto.
Oxford mantiene numerosi bonus, non da ultimo quello di rappresentare una tradizione intellettuale particolare, uno stile comune di pensiero e discussione, meticoloso, empirico, scettico, ironico, di cui si è fatto ampio sfoggio nel dibattito alla Sheldonian Theatre. Ma oggigiorno una quantità spaventosa del tempo accademico di Oxford è presa da procedure burocratiche, molte delle quali direttamente o indirettamente imposte dal governo e dalle preoccupazioni economiche. Trovo che i docenti universitari a Stanford passino molto meno tempo a parlare di denaro rispetto alle loro controparti di Oxford, avendone a disposizione una maggiore quantità. Trovo anche che le grandi università americane, sia pubbliche che private, Berkeley come Stanford, hanno più fiducia in se stesse. Raramente dubitano di avere un ruolo vitale nello sviluppo delle rispettive società, alla pari delle imprese, dei tribunali, dei media o degli enti erogatori di prestazioni sanitarie.
Dietro tutto questo c’è una questione di più ampia portata. La Gran Bretagna, come la Francia e la Germania, spende solo l’1,1 per cento del Pil per l’istruzione terziaria. Gli Stati Uniti spendono il 2,6 per cento, di cui l’ 1,4percento deriva da fonti private e l’1,2 per cento da finanziamenti pubblici. In altri termini la spesa pubblica americana per l’istruzione superiore è maggiore della nostra spesa complessiva, pubblica e privata.
Dietro tutto questo c’è una questione di più ampia portata. La Gran Bretagna, come la Francia e la Germania, spende solo l’1,1 per cento del Pil per l’istruzione terziaria. Gli Stati Uniti spendono il 2,6 per cento, di cui l’ 1,4percento deriva da fonti private e l’1,2 per cento da finanziamenti pubblici. In altri termini la spesa pubblica americana per l’istruzione superiore è maggiore della nostra spesa complessiva, pubblica e privata.
L’Europa chiacchiera di"economia basata sulla conoscenza", loro fanno i fatti. E sono seguiti, con grinta, dalle economie asiatiche in crescita. Che fare? Una alternativa sarebbe che i contribuenti europei pagassero notevolmente di più per le loro maggiori università nazionali. È un’ipotesi probabile quanto l’eventualità che il Colosseo si sposti a Nottingham. Un’altra opzione per l’Europa sarebbe la condivisione delle risorse. È avvenuto con notevoli risultati nei laboratori di fisica delle particelle del Cern, culla del Web. Ma non riesco a immaginare che un grande paese europeo accetti di veder collocare l’unico dipartimento europeo di storia di livello mondiale in Francia, a patto che l’unico dipartimento di geografia di livello mondiale si trovi in Germania.
La terza opzione è quella verso cui Oxford si sta orientando, al solito, per vie traverse: un modello che combini finanziamento pubblico e privato, senza asservirsi al modello delle grandi università americane, che hanno le loro pecche, ma traendo alcuni spunti dal loro operato. Gli spunti saranno diversi a seconda dei casi. Nel caso di Oxford prenderemo una serie di iniziative strettamente connesse. Organizzeremo la nostra campagna di raccolta fondi, che ad Oxford vuol dire coordinare le iniziative dei college e dell’università centrale. A giudizio di Sir Peter Lampi un filantropo che ha studiato a fondo la questione, Oxford raccoglie contributi da meno del 10 per cento dei suoi ex alunni, mentre Princeton li ottiene da più del 60 %. È una cosa assurda e la colpa è soprattutto nostra, anche se qualche modifica alla normativa fiscale sulle donazioni caritatevoli sarebbe d’aiuto. Poi chiederemo al governo e al parlamento britannico di portare 1e tasse universitarie diciamo a 10.000 sterline l’anno, il che equivale a circa due terzi del livello di Stanford contro il quinto attuale. Il ministro delle finanze e probabile futuro premier Gordon Brown ha detto che prenderà in esame la proposta al momento di rivedere, nel 2008,l’attuale tetto imposto alle rette e uno degli obiettivi non dichiarati della proposta di riforma gestionale di Oxford è proprio quello di favorire questa possibilità.
L’aumento delle tasse universitarie esige un altro tipo di intervento, praticato dalle migliori università americane, ovvero fornire adeguate borse di studio ai molti studenti promettenti che non potrebbero permettersi di affrontare rette del genere. Nel contesto britannico significherà anche raddoppiare gli sforzi per far sì che gli studenti di estrazione meno abbiente e provenienti dalie scuole statali non siano scoraggiati dalla combinazione di elevate tasse universitarie, l’ onere dei prestiti statali per mantenersi agli studi e l’immagine di una Oxford da damerini (ben lontana dalla realtà di oggi). La prassi americana di offrire agevolazioni per l’ammissione ai figli di ex alunni e di generosi donatori, che ha permesso a George Bush di entrare a Yale, sarebbe del tutto inaccettabile qui. Perché Oxford è, dopo tutto, una città europea.
La terza opzione è quella verso cui Oxford si sta orientando, al solito, per vie traverse: un modello che combini finanziamento pubblico e privato, senza asservirsi al modello delle grandi università americane, che hanno le loro pecche, ma traendo alcuni spunti dal loro operato. Gli spunti saranno diversi a seconda dei casi. Nel caso di Oxford prenderemo una serie di iniziative strettamente connesse. Organizzeremo la nostra campagna di raccolta fondi, che ad Oxford vuol dire coordinare le iniziative dei college e dell’università centrale. A giudizio di Sir Peter Lampi un filantropo che ha studiato a fondo la questione, Oxford raccoglie contributi da meno del 10 per cento dei suoi ex alunni, mentre Princeton li ottiene da più del 60 %. È una cosa assurda e la colpa è soprattutto nostra, anche se qualche modifica alla normativa fiscale sulle donazioni caritatevoli sarebbe d’aiuto. Poi chiederemo al governo e al parlamento britannico di portare 1e tasse universitarie diciamo a 10.000 sterline l’anno, il che equivale a circa due terzi del livello di Stanford contro il quinto attuale. Il ministro delle finanze e probabile futuro premier Gordon Brown ha detto che prenderà in esame la proposta al momento di rivedere, nel 2008,l’attuale tetto imposto alle rette e uno degli obiettivi non dichiarati della proposta di riforma gestionale di Oxford è proprio quello di favorire questa possibilità.
L’aumento delle tasse universitarie esige un altro tipo di intervento, praticato dalle migliori università americane, ovvero fornire adeguate borse di studio ai molti studenti promettenti che non potrebbero permettersi di affrontare rette del genere. Nel contesto britannico significherà anche raddoppiare gli sforzi per far sì che gli studenti di estrazione meno abbiente e provenienti dalie scuole statali non siano scoraggiati dalla combinazione di elevate tasse universitarie, l’ onere dei prestiti statali per mantenersi agli studi e l’immagine di una Oxford da damerini (ben lontana dalla realtà di oggi). La prassi americana di offrire agevolazioni per l’ammissione ai figli di ex alunni e di generosi donatori, che ha permesso a George Bush di entrare a Yale, sarebbe del tutto inaccettabile qui. Perché Oxford è, dopo tutto, una città europea.
Sono queste le cose che determineranno il futuro di Oxford. La riforma gestionale proposta è semplicemente un mezzo per raggiungere un fine più ampio. Potrà sembrare un atteggiamento ossequioso alle richieste del governo, ma l’obiettivo a lungo termine è opposto: renderci meno dipendenti dallo stato e più in grado di mantenere l’eccellenza accademica e l’indipendenza partendo dalle nostre risorse e a modo nostro. Ecco perché (in caso ancora ve lo chiediate) personalmente appoggio la riforma, con tutte le sue imperfezioni.
Se Oxford saprà compiere questi passi cruciali riuscirà forse a mantenere la posizione di università di ricerca di livello mondiale. Mala scelta non si pone solo ai votanti di Oxford. Sipone anche agli elettori britannici e, più in generale, alle società europee. Queste ultime sceglieranno forse alla fine di preferire l’istruzione superiore di massa, a libero accesso, a basso costo, come bene sociale e di abbandonare l’aspirazione che le università europee hanno nutrito da quando Wilhelm von Humboldt inventò il modello della moderna università duecento anni fa, ovvero coniugare l’insegnamento universitario alla ricerca di livello mondiale. Se andremo avanti così, di certo faremo quella fine. Facciamo almeno in modo che l’Europa, come Oxford, apra un ampio dibattito e operi una scelta consapevole.
Timothy Garton Ash
Timothy Garton Ash
www.timothygartonash.rom
traduzione Emilia Benghi
10 - Corriere della Sera del 3 dicembre 2006
Lo sciopero fiscale dei rettori: non ridaremo i soldi allo Stato
Il via dal numero uno di Padova (vicino all’Unione), poi Tor Vergata e Modena
Milano. A dire «disobbedienti», nel Nordest che ha assistito alla nascita delle tute bianche di Casarini, tutto verrebbe in mente tranne l’ermellino di Vincenzo Milanesi, rettore dell’ateneo di Padova. Eppure la disobbedienza è lì, nero su bianco, nella delibera del Consiglio d’amministrazione: calcolato in 7 milioni di euro il «taglio» imposto dal decreto Visco-Bersani al funzionamento ordinario 2007-2009, «il Cda ritiene impossibile versare per il momento quanto previsto dalla norma "tagliaspese"». Uno sciopero fiscale in piena regola, contro un provvedimento che colpisce bilanci già sofferenti. E più d’uno ha deciso di seguirne l’esempio.
Milano. A dire «disobbedienti», nel Nordest che ha assistito alla nascita delle tute bianche di Casarini, tutto verrebbe in mente tranne l’ermellino di Vincenzo Milanesi, rettore dell’ateneo di Padova. Eppure la disobbedienza è lì, nero su bianco, nella delibera del Consiglio d’amministrazione: calcolato in 7 milioni di euro il «taglio» imposto dal decreto Visco-Bersani al funzionamento ordinario 2007-2009, «il Cda ritiene impossibile versare per il momento quanto previsto dalla norma "tagliaspese"». Uno sciopero fiscale in piena regola, contro un provvedimento che colpisce bilanci già sofferenti. E più d’uno ha deciso di seguirne l’esempio.
LA PROTESTA
«AL Cda ho detto solo: non possiamo disdire i contratti già firmati. Se non paghiamo l’Enel, ci tocca la penale e il blocco delle attività. Sa, Padova non ha un clima che induca a stare senza riscaldamento, d’inverno». Non è un barricadero il professor Milanesi, rettore dal 2002, una vicinanza non dichiarata al centrosinistra (in città lo ricordano ad accogliere il pullman di Prodi, e a un certo punto si vociferò di una sua
«AL Cda ho detto solo: non possiamo disdire i contratti già firmati. Se non paghiamo l’Enel, ci tocca la penale e il blocco delle attività. Sa, Padova non ha un clima che induca a stare senza riscaldamento, d’inverno». Non è un barricadero il professor Milanesi, rettore dal 2002, una vicinanza non dichiarata al centrosinistra (in città lo ricordano ad accogliere il pullman di Prodi, e a un certo punto si vociferò di una sua
candidatura per la Margherita). La sua è una decisione presa «senza pervicacia ideologica»: negli ultimi anni Padova ha già restituito oltre 4,5 milioni, rosicchiati dalle spese di funzionamento. «Ma qui, appunto, non si considera la diversità fra atenei; capirei se si agisse su chi supera certe soglie, magari attivando il rappresentante del ministero dell’Economia nel Collegio dei revisori dei conti,..». Invece, le forbici del decreto calano per tutti: -10% sui consumi intermedi (bollette, vigilanza, manutenzione) del 2006, -20% sulle previsioni di bilancio 2007. Sono i soldi che Padova ha deciso di non restituire, con una delibera trasmessa ai dicasteri di Economia e Sviluppo economico. E a quello dell’Università, «ben consapevole della ragionevolezza di questa posizione». Reazioni ufficiali, nessuna. Milanesi è ottimista, ma con giudizio: «Nel Discorso sul metodo, Cartesio diceva che il senso comune è la cosa più diffusa sulla Terra. Purtroppo, a volte il buon senso fa difetto ai politici».
SULLE ORME DI PADOVA
La «disobbedienza civile» che soffia dal Nordest non sembra dispiacere ai rettori: «Abbiamo approvato la stessa delibera, per 5-6 milioni di euro - dichiara Alessandro Finazzi Agrò, che governa Tor Vergata dal 1996 -. Tagliare significa chiudere un giorno alla settimana. Qui c’è il policlinico, i laboratori: che faccio, spengo il condizionamento ai topi? II decreto, poi, si applica anche alle risorse proprie degli atenei: una misura kafkiana...». Una scelta a rischio, «ma la nostra è una linea di difesa. Se l’autorità giudiziaria mi dicesse che sono un malfattore, non avrei difficoltà a rimettere il mandato. Altrimenti, per stare a galla, dovrei fare falsi in bilancio. No, grazie». Gian Carlo Pellacani, dal 1999 alla guida dell’università di Modena e Reggio Emilia, sottoscrive: «Credo che questo decreto sia anticostituzionale. Noi facciamo come Padova, martedì porterò la delibera in cda. Non restituiremo 2 milioni di euro». A Bologna la cifra è più alta, «circa 8 milioni- fa il punto il rettore Pier Ugo Calzolari -. Per ora nessuna delibera formale, ma in settimana affronteremo il tema del bilanciò. E valuteremo con attenzione anche questa possibilità».
L’APPELLO DELLA CRUI
Tra chi ha chiesto copia della delibera padovana c’è anche Stefania Giannini, Università per Stranieri di Perugia, 6.000 studenti non italiani (non finanziati dal fondo ordinario) su 8.000 «e un bilancio di 33 milioni. Il taglio del 10% si può sopportare, il20% sarebbe devastante. Sugli enti di ricerca un ripensamento c’è stato, ma per noi?». L’interrogativo serpeggia tra i «magnifici», e infatti la Conferenza dei rettori, spiega il presidente Guido Trombetti, «ha chiesto che l’università sia sottratta al Bersani, al pari di scuola ed enti di ricerca. Certo non è il 2007 l’anno adatto per il rilancio, ma almeno niente tagli... Mi sembra, comunque, che ci sia grande ascolto; ho fiducia che le nostre istanze saranno accolte». «Noi questa speranziella la coltiviamo - conclude Marco Pacetti, Politecnico delle Marche (tagli previsti: 1,5 milioni) -. Ma come extrema ratio, stiamo pensando al ricorso alla Corte costituzionale. Insieme a Padova e ad altri atenei».
Gabriela Jacomella
La «disobbedienza civile» che soffia dal Nordest non sembra dispiacere ai rettori: «Abbiamo approvato la stessa delibera, per 5-6 milioni di euro - dichiara Alessandro Finazzi Agrò, che governa Tor Vergata dal 1996 -. Tagliare significa chiudere un giorno alla settimana. Qui c’è il policlinico, i laboratori: che faccio, spengo il condizionamento ai topi? II decreto, poi, si applica anche alle risorse proprie degli atenei: una misura kafkiana...». Una scelta a rischio, «ma la nostra è una linea di difesa. Se l’autorità giudiziaria mi dicesse che sono un malfattore, non avrei difficoltà a rimettere il mandato. Altrimenti, per stare a galla, dovrei fare falsi in bilancio. No, grazie». Gian Carlo Pellacani, dal 1999 alla guida dell’università di Modena e Reggio Emilia, sottoscrive: «Credo che questo decreto sia anticostituzionale. Noi facciamo come Padova, martedì porterò la delibera in cda. Non restituiremo 2 milioni di euro». A Bologna la cifra è più alta, «circa 8 milioni- fa il punto il rettore Pier Ugo Calzolari -. Per ora nessuna delibera formale, ma in settimana affronteremo il tema del bilanciò. E valuteremo con attenzione anche questa possibilità».
L’APPELLO DELLA CRUI
Tra chi ha chiesto copia della delibera padovana c’è anche Stefania Giannini, Università per Stranieri di Perugia, 6.000 studenti non italiani (non finanziati dal fondo ordinario) su 8.000 «e un bilancio di 33 milioni. Il taglio del 10% si può sopportare, il20% sarebbe devastante. Sugli enti di ricerca un ripensamento c’è stato, ma per noi?». L’interrogativo serpeggia tra i «magnifici», e infatti la Conferenza dei rettori, spiega il presidente Guido Trombetti, «ha chiesto che l’università sia sottratta al Bersani, al pari di scuola ed enti di ricerca. Certo non è il 2007 l’anno adatto per il rilancio, ma almeno niente tagli... Mi sembra, comunque, che ci sia grande ascolto; ho fiducia che le nostre istanze saranno accolte». «Noi questa speranziella la coltiviamo - conclude Marco Pacetti, Politecnico delle Marche (tagli previsti: 1,5 milioni) -. Ma come extrema ratio, stiamo pensando al ricorso alla Corte costituzionale. Insieme a Padova e ad altri atenei».
Gabriela Jacomella
11 - Il Sole 24 Ore del 27 novembre 2006
E-learning: in ordine sparso
In assenza di regole generali prevalgono le sperimentazioni
Formazione a distanza. Uno studio UE evidenzia livelli di sviluppo diversi peri corsi universitari
Il professore si alza molto presto al mattino, decisamente prima dello studente. Mentre quest’ultimo, caffelatte in una mano e mouse nell’altra, si trascina in pantofole e pigiama, davanti al video dei suo pc, il docente-tutor, è già li pronto. Rasato di fresco, abbigliamento casual, sprizza energia da tutti pori; e uscendo da un’animazione colorata apostrofa il suo allievo puntandogli familiarmente il dito della mano destra «How are you? Are you ready?». Negli Stati Uniti si usa lo stile friendly e qualche volta il ritmo del videogame, per coinvolgere gli studenti in una sessione d’insegnamento a distanza. Poi arrivano le banche dati, i materiali da acquisire, le esercitazioni interattive, e più recentemente anche chat e blog.In alcune università il contatto rimane virtuale, e gli incontri vis à vis con i professori si contano a fine corso sulle dita di una mano; per le grandi distanze, e dell’e-learning pensato come uno strumento che può avvicinare la provincia dell’Ohio alla Columbia University. Nella nostra più piccola Europa tutto è permesso o quasi. La modalità più usata, che calibra Internet e supporti tecnologici con la presenza in aula e il contatto con il docente, è solitamente blended, integrata cioè con un massimo del 50% di aula virtuale. Nonostante gli sforzi della Commissione europea con i progetti di campus virtuali, azioni trasversali e consorzi tra atenei, non c’è una regolamentazione unitaria. Persiste la nebulosa di sperimentazioni e iniziative autonome di cattedratici che portano avanti la causa, senza un vero supporto a livello istituzionale. In Italia più che in Europa.
Tra le iniziative di promozione dell’e-learning avviate dalla Ue c’è il progetto Elue, che presenta i risultati di un’indagine della Conferenza dei rettori delle università italiane, dalla Conference des presidents d’université francaise e da Finnish virtual university sugli atenei dei rispettivi Paesi. Finlandia, Francia e Italia a confronto sulle politiche, le risorse, le tecnologia utilizzate e il grado d’innovazione. È evidente una diversa sensibilità politica delle istituzioni governative nei confronti delle politiche di finanziamento dell’e-learning. Infatti, in Francia e Finlandia, il sistema d’istruzione universitaria si avvantaggia di stanziamenti pubblici espressamente destinati alla promozione dell’e-learning, contrariamente a quanto avviene in Italia.
In Finlandia dal 2001, il ministero dell’Istruzione ha assegnato annualmente agli atenei nove milioni di euro per lo sviluppo delle università virtuali, così sono stati realizzati negli anni quasi mille corsi online, equivalenti a circa 2.500 settimane di studio.
In Francia negli ultimi dieci anni, sono stati adottati due tipi di provvedimenti: il sostegno ai progetti degli atenei come parte delle strategie di accordo tra il governo e le università; il finanziamento dei progetti comuni interuniversitari di sviluppo di risorse multimediali, di digital campus, università digitali regionali e la creazione di ambienti di lavoro digitali.
In Italia invece gli atenei hanno autonomamente scelto di destinare parte del proprio budget a tali attività, senza guida legislativa né aiuto finanziario. Si distinguono due eccezioni: il progetto CampusOne della Crui che ha promosso, tra il 2001 C il 2004, anche l’adozione delle nuove tecnologie per la didattica e il decreto Moratti-Stanca (17 aprile 2003) che istituisce in Italia le università telematiche, attualmente oggetto di qualche ripensamento: «I benefici sono di poco conto, non si prevedono incentivi agli atenei» sottolinea la ricerca Crui Elue.
Lo scenario finlandese è quello più sviluppato per la reale diffusione dell’e-learning nelle università, del contenuto tecnologico e innovativo. La Francia si distingue per la partecipazione a network e a piattaforme internazionali, nonché sul fronte tecnologico, con l’acquisto di attrezzature, sviluppo della rete, e per un’importante attività di ricerca.
In Francia negli ultimi dieci anni, sono stati adottati due tipi di provvedimenti: il sostegno ai progetti degli atenei come parte delle strategie di accordo tra il governo e le università; il finanziamento dei progetti comuni interuniversitari di sviluppo di risorse multimediali, di digital campus, università digitali regionali e la creazione di ambienti di lavoro digitali.
In Italia invece gli atenei hanno autonomamente scelto di destinare parte del proprio budget a tali attività, senza guida legislativa né aiuto finanziario. Si distinguono due eccezioni: il progetto CampusOne della Crui che ha promosso, tra il 2001 C il 2004, anche l’adozione delle nuove tecnologie per la didattica e il decreto Moratti-Stanca (17 aprile 2003) che istituisce in Italia le università telematiche, attualmente oggetto di qualche ripensamento: «I benefici sono di poco conto, non si prevedono incentivi agli atenei» sottolinea la ricerca Crui Elue.
Lo scenario finlandese è quello più sviluppato per la reale diffusione dell’e-learning nelle università, del contenuto tecnologico e innovativo. La Francia si distingue per la partecipazione a network e a piattaforme internazionali, nonché sul fronte tecnologico, con l’acquisto di attrezzature, sviluppo della rete, e per un’importante attività di ricerca.
ITALIA. POCHI CASI ALL’AVANGUARDIA
Solo il 10 per cento di iscritti
Solo il 10 per cento di iscritti
Se nel confronto con Francia e Finlandia, l’Italia sembra fare da fanalino di coda, non mancano gli esempi d’innovazione. Il numero di studenti italiani che usufruiscono di istruzione a distanza indica un fenomeno circoscritto: le 77 università italiane non attirano più del 10% degli iscritti nei corsi a distanza. Gli utenti di didattica a distanza lo fanno in atenei che praticano in misura rilevante la videoconferenza o la didattica via web, anche con tecnologie innovative. Come a dire, pochi ma buoni.
È un fatto che l’esperienza di CampusOne, il progetto di e-earning attivo nel triennio 2001-2004, abbia coinvolto 70 atenei, con un investimento di 180 milioni di euro e che abbia lasciato un’eredità importante in termini di sviluppo e durata dei progetti, oggi portati avanti dalle singole università. Maturano in alcuni atenei italiani progetti di piattaforme tecnologiche innovative per l’e-learning e sistemi sofisticati che possono stare al passo con l’esperienza internazionale: dall’Università di Udine, al Politecnico di Milano, Tor Vergata (Roma), tra le altre.
Una vera autorità in materia è Furio Honsel, rettore dell’università di Udine, che vede nell’uso dei sistemi digitali una grande opportunità per l’e-learning: «Il digital learning permette di incrementare la flessibilità della didattica sia in termini di tàrget di studenti che di accessibilità spaziale e temporale -dice - ma non solo, pensiamo alla modularità, la riusabilità e dei materiali e la tracciabilità. Tutto ciò conduce a una didattica di qualità migliore, più centrata sullo studente».
Loredana Oliva
12 - Il Riformista del 5 dicembre 2006
A proposito di un articolo di Perotti
Quei paragoni con l’estero fatti a uso degli amici
Università. Nella comparazione tra il sistema italiano e quello britannico i dati sono strumentalizzati per dimostrare una propria tesi preconfezionata
Finalmente, le «sacre scritture» più volte citate negli articoli di Giavazzi, Alesina e altri economisti, che dichiarano irrimediabile la condizione dell’università italiana, e suggeriscono al governo di tagliarne i finanziamenti, sono disponibili a tutti. Lo stesso “Profeta”, autore delle «sacre scritture», il citatissimo professor Roberto Perotti, ne ha pubblicato una versione aggiornata, avendo a disposizione un’intera pagina del Sole24Ore del 30 novembre. Si può ora discutere, in qualche dettaglio, una fonte acriticamente invocata come certa e inoppugnabile, dai teologi del Dio Mercato che continuano a dominare le pagine dei grandi quotidiani sui problemi dell’università. Si può finalmente osservare che l’articolo di Perotti è un esempio da manuale di come dati statistici apparentemente obiettivi possano essere messi al servizio di una tesi preconcetta.
La tesi di Perotti è che il sistema universitario britannico è molto più efficiente e produttivo di quello italiano, come testimoniato dalla spesa media per studente e dal rapporto studenti/docenti nei due paesi.
Che dire innanzitutto di questa tesi? Io penso che ci sia moltissimo da imparare dall’esperienza inglese nelle politiche dell’istruzione superiore, e in particolare dalla loro capacità di adottare politiche coraggiose e di analizzarne gli effetti per correggerne il tiro, anche radicalmente. Tuttavia un confronto diretto tra i sistemi universitari dei due paesi sulla base di dati grossolani non ha proprio senso. In Gran Bretagna il sistema universitario è, per la metà circa, costituito da università, che sono nate come istituzioni parauniversitarie, dove ai docenti non veniva nemmeno chiesto di impegnarsi nella ricerca. In molti casi l’istruzione fornita da queste istituzioni non era di livello molto diverso da quello che era offerto dai nostri migliori istituti tecnici. Il grande e interessantissimo esperimento inglese di valutazione della ricerca scientifica che va sotto il nome di Rae (Research assessment exercises) ha avuto principalmente l’effetto di ribadire la distinzione tra università di serie A e università di serie B, dopo che, nel 1992, tutte le istituzioni parauniversitarie erano state formalmente promosse al rango di università. In Italia, questa distinzione è impossibile, come ha testimoniato il nostro esperimento di valutazione della ricerca, che imita quello inglese, e che si è concluso quasi un anno fa. Le nostre valutazioni hanno confermato che ricerca ritenuta «eccellente» si svolge, in ogni area, in tutte le grandi e medie sedi universitarie.
Vediamo invece come il professor Perotti riesce a utilizzare dati molto grossolani per sostenere la sua tesi. Il primo dato è il rapporto tra studenti dei corsi di laurea (esclusi gli studenti laureati) e i docenti di ruolo. I numeri così ottenuti, però, non gli danno ragione. Ci sarebbero 20 studenti per docente in gran Bretagna e 30 in Italia. Giustamente, Perotti osserva che in Italia tra gli studenti vengono contati i fuori corso, che dovrebbero pesare meno in termini di impegno didattico. Introduce quindi il parametro di studente «equivalente a tempo pieno» (etp). Per la Gran Bretagna questo significa contare gli studenti dichiaratamente a tempo parziale in proporzione al loro impegno. In Italia, invece, sono considerati a tempo parziale tutti gli studenti in ritardo con gli studi, in proporzione al ritardo. In pratica, tutti gli studenti italiani sono considerati in diversa misura come studenti a tempo parziale.
Il divario tra lunghezza legale e lunghezza effettiva degli studi universitari è uno dei difetti gravi del nostro sistema, che la riforma universitaria si proponeva di correggere, e in parte ha corretto. L’assurdo era, ed è, che proprio per uno studente a tempo pieno risultava impossibile completare il corso di laurea nei tempi ufficialmente previsti. Giustamente il ministero ha introdotto, attraverso il parametro utilizzato da Perotti, una misura di questa stortura, per aiutarne la correzione, ma è una vera forzatura utilizzare questa misura per un confronto internazionale, perché molti degli studenti ritardatari sono invece effettivi studenti a tempo pieno secondo gli standard internazionali. Tuttavia nemmeno questa forzatura dei dati è sufficiente al professor Perotti per raggiungere il suo obiettivo. Anche in termini di studenti etp il rapporto studenti/docenti di ruolo risulta lo stesso nei due paesi: 15 per la Gran Bretagna, 14,9 per l’Italia. È a questo punto che Perotti è costretto, per sostenere la sua tesi, a cambiare i denominatori dei rapporti. Si aggiungono ai docenti permanenti delle università inglesi i docenti che non hanno un contratto a tempo indeterminato, e ai docenti delle università italiane i «docenti a contratto» e altre figure minori, infine ai dati sui docenti inglesi si sottraggono i non meglio determinati «docenti impegnati solo nella ricerca». A questo punto, finalmente, i dati rispondono alle aspettative del professor Perotti, il rapporto studenti/docenti scende a 9,7 per la Gran Bretagna e a 7,5 per l’Italia.
Ma chi sono i «docenti a contratto» italiani che Perotti ha introdotto nel denominatore? Nelle università statali (a quelle non statali si applica invece uno speciale codicillo) sono esperti, rigorosamente esterni ai ruoli universitari, che, di regola, non sono titolari di un insegnamento ufficiale, ma sono invitati a presentare aspetti particolari, spesso applicativi, della materia insegnata. Alle loro lezioni, che si riducono a poche ore, assiste, normalmente, anche il titolare dell’insegnamento. Aggiungere queste figure al totale dei docenti universitari italiani non ha senso ai fini comparativi, ma era assolutamente necessario per dimostrare la tesi di Perotti, e cioè che i docenti universitari italiani sono troppi. In realtà il professor Perotti non manca di rilevare (con argomenti sbagliati) che l’inclusione dei docenti a contratto nel totale dei docenti italiani dà luogo a una sovrastima del numero dei docenti, ma si guarda bene dal parlarne quando tratta del rapporto studenti/docenti. Lo nota invece, confidando nella disattenzione del lettore, quando scopre che nonostante l’uso improprio, come vedremo, di un tasso di cambio artificioso, il costo medio di un docente italiano risulterebbe inferiore a quello di un docente inglese.
La seconda tesi di Perotti è che in Italia la spesa per studente universitario è superiore (o almeno non troppo diversa) dalla spesa nel Regno Unito. Sembrerebbe naturale a un ignaro lettore di giornali, paragonare le due spese, in euro e in sterline, utilizzando il cambio ufficiale. Perotti, invece, astutamente introduce un’altra unità di misura il cosiddetto «Ppp (Purchasing power parities) dollar» che tiene conto del diverso costo della vita nei due paesi. Paragoni internazionali che utilizzano questa variabile hanno certamente senso se si vogliono confrontare i livelli di consumo delle famiglie, la distribuzione del reddito disponibile, i livelli di povertà, o i salari netti. Non ha senso invece utilizzare questa variabile per paragonare la spesa sostenuta dalle università per sostenere il servizio didattico. Cosa c’entra il prezzo del pane o del latte, o comunque il “paniere” delle spese prevalenti nelle famiglie, con le spese che deve affrontare una sede universitaria?
Per fare un esempio, nel determinare il Pppdollar non si tiene certamente conto del costo del lavoro a parità di salario netto, che in Italia, in virtù di un maggiore cuneo fiscale è superiore a quello di altri paesi. Eppure il costo del lavoro al lordo delle tasse e contributi è un elemento determinante nelle spese per una attività «labour intensive» come è quella didattica. Il buffo è che nonostante la forzatura di scegliere le due variabili addomesticate del “Ppp dollar” e dello studente Etp, la spesa media per studente (non laureato) in Gran Bretagna, risulta del 27% superiore a quella italiana. Nel Regno Unito si spendono 4.200 “Ppp dollar” in più per ogni studente Etp. Calcolando le percentuali a scalare, come astutamente fa il professor Perotti, il divario scende al 20%. Tanto basta per far proclamare a Perotti che si tratta di un «divario non drammatico».
V’è un’altra interessante omissione che deve esse rilevata. Il professor Perotti non può non ricordare che nel suo scritto originario, che utilizza i dati del 1999-2000, la spesa media per studente italiano, calcolata sempre in termini di studenti Etp e di “Ppp dollari” era molto superiore alla spesa per studente inglese. Dal 2000 al 2004 la spesa media per studente Etp (non laureato) in Italia è scesa da 16.854 a 15.400 “Ppp dollar”, mentre, calcolata allo stesso modo, in Gran Bretagna è cresciuta da 12.435 a 19.600 “Ppp dollar”. Si sono invertite in termini di percentuali le posizioni dell’Italia e della Gran Bretagna. Per chi, come me, non crede a queste stime grossolane, queste variazioni non hanno molto significato. Come è possibile tuttavia che il professor Perotti, che sembra credere a queste stime, non abbia concluso dai suoi stessi dati che l’università italiana è avviata a un luminoso futuro avendo superato il sistema inglese in termini di efficienza?
Dobbiamo alla fine chiederci come sia possibile che uno stimato economista si dedichi a simili equilibrismi con dati statistici non sufficientemente disaggregati. Come è possibile che altri stimati studiosi lo citino acriticamente? La risposta, io credo, è nelle passioni suscitate nel professor Perotti e negli altri professori che scrivono sull’università, dal vero problema che sta loro a cuore, che non sono le sorti degli studenti o del Paese, ma piuttosto l’esito dei concorsi a cattedra nelle loro discipline. Per questo dobbiamo esser grati al professor Perotti, che non si è limitato, come molti suoi colleghi, a pochi accenni al problema che gli sta veramente a cuore, ma ha pubblicato nella pagina messagli a disposizione dal Sole24ore un piccolo saggio sulle beghe concorsuali del suo settore disciplinare. Uno scritto incomprensibile, credo, alla maggioranza dei lettori, me compreso, che testimonia però dove batte il cuore dell’autore. Se il cuore batte sulle beghe concorsuali, sui contrasti tra scuole diverse, sulle «capre» o gli «asini» che vengono promossi, scavalcando i nostri allievi, i nostri amici o noi stessi, non si può guardare con occhio equanime il sistema universitario. Il problema delle promozioni di quarantenni o cinquantenni che già insegnano nelle università è importantissimo per i diretti interessati, le loro famiglie, i loro amici e i loro sostenitori, ma è di scarso rilievo per l’università, la ricerca e gli studenti.
Alessandro Figà Talamanca
Università La Sapienza di Roma
Università La Sapienza di Roma

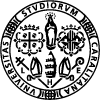 University of Cagliari
University of Cagliari
